A proposito di "Tempi duri"
La storia di Vargas
Il nuovo, bellissimo romanzo di Mario Vargas Llosa ricama alla perfezione sulla vera storia del golpe (guidato dagli americani) che nel 1954 pose fine all'illusione democratica in Guatemala. Un perfetto lavoro tra finzione e realtà
Eravamo tutti pronti a consegnare il vecchio Varguitas al museo delle cere della grande letteratura. Le sue opere più recenti avevano deluso e indispettito, e i critici erano pronti a recitare il de profundis per lo scrittore ultraottantenne che – come scrive il settimanale spagnolo El cultural – «aveva dato negli ultimi tempi segni premonitori di decadenza». Eravamo pronti – dicevo – e invece il vecchio leone è tornato a ruggire e ci ha consegnato, con Tempi duri un grande romanzo civile (Einaudi, 328 pagine, 20 Euro, traduzione di Federica Niola). Opera sorprendente per vigore giovanile e piglio giornalistico, dedicata al peccato originale della lunga stagione delle dittature in Centroamerica: il colpo di Stato che nel giugno del 1954 rovesciò in Guatemala il governo riformatore di Jacobo Arbenz.
Fu quello – e Vargas Llosa lo spiega nei particolari – un modello per tutte le successive prove di forza contro gli esperimenti democratici: una macchinazione ispirata dai giganteschi interessi economici della compagnia bananiera United Fruit, organizzata dalla Cia e dall’ambasciata di Washington, sostenuta dal governo Eisenhower con armi e vagonate di dollari, spalleggiata dai vertici della chiesa cattolica e da tutti i dittatori dei Paesi fratelli della regione.
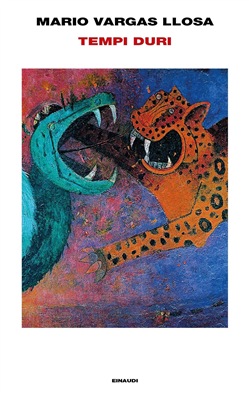
Jacobo Arbenz doveva essere punito per aver commesso il peccato più odioso: il varo di una riforma agraria che concedeva le terre incolte ai contadini poveri, riscattando gli indigeni miserabili del Guatemala. Per questo il governo fu accusato del reato infamante di comunismo, presidente e ministri perseguitati, i militari rimasti fedeli umiliati e incarcerati, la capitale messa a ferro e fuoco, le campagne attraversate da una ventata di terrore sanguinario, i contadini ricacciati a forza in una miseria senza scampo.
Nella sua nuova opera Vargas Llosa compie il piccolo capolavoro di trasformare la verità della cronaca in romanzo, scandito da intrighi e colpi di scena. I suoi protagonisti sono gli stessi dei libri di storia: dall’infelice presidente Arbenz al generale golpista Carlos Castillo Armas, dall’ ambasciatore-sceriffo americano Emil Peurifoy al dittatore dominicano Rafael Trujillo, per finire con gli assassini prezzolati Enrique Oliva e Johnny Abbes Garcia.
Per trecento pagine, e come nelle sue prove maggiori, lo scrittore cammina in difficile e ammirevole equilibrio tra storia e finzione. Infine, quando le ceneri del dramma si posano sui fuochi ormai spenti, l’autore getta la maschera e si trasforma in cronista. Succede nell’ultimo capitolo, quando Vargas Llosa descrive il suo incontro reale con la protagonista femminile della storia. Così, nel salotto tutto trine e ninnoli di vetro di una modesta villetta suburbana tra Washington e la Virginia, l’ospite ottantenne conversa piacevolmente con la vecchia signora che in un tempo remoto fu la bellissima amante del dittatore guatemalteco Castillo Armas. Il confronto è un garbato ma aspro duello.
Sulla porta, al momento del commiato, il saluto di Gloria Bolanos Pons, alias Marta Borrero, è definitivo e minaccioso. «Non si disturbi a mandarmi il suo libro quando uscirà, don Mario. In ogni caso non lo leggerò. Ma l’avverto: lo leggeranno i miei avvocati».

A mezzo secolo da Conversacion en la Catedral, a quaranta anni da La guerra del fin del mundo, a venticinque da Lituma en los Andes, a venti da La fiesta del chivo, Vargas Llosa torna a calpestare da cronista ispirato la polvere del Continente. Brilla ancora il suo antico demone, che sembrava spento nel dorato esilio di Madrid; e la sua ossessione ancora brucia, anche se in un romanzo imperfetto. Oggi non sono più quei tempi feroci, ammette lo scrittore: «Tutto va male, ma non siamo mai stati meglio», e si riferisce certo all’America Latina, dove le dittature di un tempo sono rimpiazzate da imperfettissime democrazie.
Come in molti romanzi del premio Nobel anche in queste pagine la tragedia e l’umana pietà scorrono sotto la superficie come una corrente carsica. I personaggi, andate pure a cercarli uno per uno nei libri di storia: sono tutti umanamente cattivi e cattivissimi. L’unico eroe positivo – l’uomo che voleva riscattare dalla miseria mezzo milione di contadini guatemaltechi – finisce per morire in esilio, forse di crepacuore, forse ucciso per vendetta. Ma se non ci sono i cattivi, finisce la letteratura, e per noi scrittori questa è una strada obbligata, spiega Vargas Llosa in una lunga intervista a El Paìs. «I cattivi hanno un fascino speciale per i romanzieri. Se fossero eliminati, metà della letteratura europea e metà di quella universale sarebbe spazzata via. In un contesto letterario i cattivi sono più interessanti dei buoni. I Paesi che vanno bene, che progrediscono, producono scarsa letteratura. Se lo lasci dire: i romanzieri svizzeri sono alla disperata ricerca di catastrofi».

