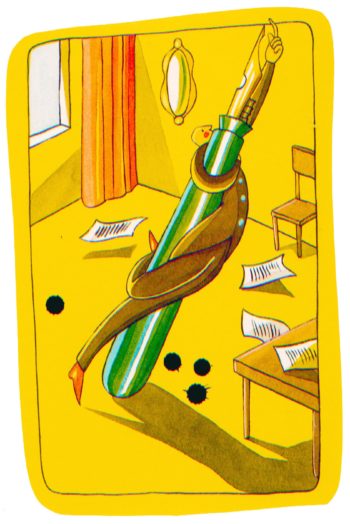Lo scaffale degli editori
Dante e la bomba
Castelvecchi con coraggio pubblica un saggio di Carter P. Hydrick sull'atomica che sarebbe stata scoperta dai tedeschi e venduta agli Usa... Mentre Nicola Bultrini rievoca tutti i "detenuti" che si sono salvati leggendo Dante e la Commedia
Con coraggio, l’editore Castelvecchi pubblica un saggio storico controcorrente, volutamente ignorato dalla Rete, dove ormai ci si approvvigiona di informazioni e letture anche revisioniste. È L’atomica nazista di Carter P. Hydrick (380 pagine, 23,50 euro), nel 2016 alla terza edizione in Usa (la prima data 2004) ma mai uscito in traduzione italiana. A cimentarsi con il testo inglese uno storico appassionato, Francesco Maria Fabbrocile, anche curatore del volume e “mente” dell’operazione editoriale. Si deve appunto alle sue ricerche e alle correlazioni tra articoli, romanzi, fonti archivistiche l’interesse verso un’opera esplosiva, già nel sottotitolo: “Come la Germania di Hitler riuscì a produrre l’uranio arricchito ad Auschwitz e a usarlo per trattare con gli Usa”. Perché proprio di questa “verità indicibile” – così la definisce Fabbrocile nell’introduzione – si tratta: non furono gli americani a inventare la bomba atomica con la quale vinsero la Seconda Guerra Mondiale ma furono i tedeschi, ormai in rotta, a cedere agli yankees testate atomiche e tecnologie di innesco che avevano messo a punto con un anno di anticipo rispetto agli statunitensi.

Se Hydrick giunse a queste conclusioni dopo tre lustri di ricerche d’archivio e d’inchiesta, Fabbrocile si è convinto della necessità di rilanciare lo studio in seguito “alla rilettura di più storie”. Soprattutto di Se questo è un uomo di Primo Levi. E infatti il prigioniero Levi, laureato in chimica, fu messo, come altri 40 mila deportati-schiavi, a lavorare nella Buma di Auschwitz, una gigantesca industria dove, ufficialmente, si effettuava la polimerizzazione. Ma in quattro anni dalla fabbrica non «uscì mai un chilogrammo di gomma sintetica». Levi ha dei sospetti e Fabbrocile li incrocia con un altro brano dello scrittore suicida: nel racconto Uranio de Il sistema periodico narra la testimonianza di un suo collega, Bonino: al quale due tedeschi schizzati fuori da un aereo atterrato in un campo chiedono la direzione verso la Svizzera. Bonino gliela indica e quelli, ringraziando, gli regalano un sasso che emana calore. «Questo è uranio, lo tenga da conto». Insomma, si era alla fine del conflitto, i tedeschi erano ormai sicuri della sconfitta e l’uranio arricchito (probabilmente prodotto in segreto a Buma) non gli serviva più.
Altro raccorda Fabbrocile: gli articoli di Luigi Romersa, vicino al Mussolini di Salò, il quale nell’autunno del ’44 assistette all’esperimento nucleare nazista su un’isoletta baltica; le foto scattate casualmente da due aviatori sudafricani proprio del complesso industriale di Auschwitz i cui negativi furono consegnati nel ’79 da Jimmy Carter al premio Nobel Elie Wiesel che commentò: «Il mondo sapeva e ha mantenuto il silenzio».
Il fatto è che i nazisti avrebbero ceduto di nascosto l’uranio arricchito agli americani avendone in cambio la «protezione dei più alti papaveri del nazismo, Martin Borman in testa» oltre alla tutela dei capitali che Hitler aveva ammassato nei Paesi occupati. Sarebbe stato l’affare del secolo concluso sottobanco con il fine, da parte di Washington, di tenere a bada i sovietici, specie nello scacchiere asiatico. Insomma, sarebbe stata Mosca, cui andavano elogi di facciata, il vero nemico: prima dei nazisti, poi degli statunitensi. Sicché la storia dal ’45 in poi andrebbe riscritta seguendo la traccia di Hydrick. Che per questo rimane fuori dal “mainstream mediatico”.

Se Primo Levi durante il lavoro al Chemiker Kommando della Buma ricorda l’Ulisse dantesco nella folle volontà di oltrepassare ogni limite consentito, molti altri sono i letterati, gli artisti, i semplici prigionieri che si sono affidati ai versi del Sommo Poeta durate la detenzione. È il tema di Con Dante in esilio (Ares Edizioni, 176 pagine, 14,90 euro) di un accorto poeta e instancabile promotore di poesia, Nicola Bultrini. Un modo originale di rendere omaggio al settimo centenario della morte di Alighieri: rintracciare appunto le testimonianze di quanti si sono affidati alla lettura della Divina Commedia (ma anche all’arte) per arginare l’abbandono della reclusione. Anche qui si impongono le esperienze nei campi di concentramento, dei quali nei due capitoli iniziali Bultrini fa una sorta di esegesi, rintracciando l’origine dell’uso del filo spinato – “barbed wire” –, a partire dalla Guerra di Secessione americana.
Ma anche per i reclusi in trincea, durante la Grande Guerra, le terzine di Dante erano un appiglio per ripensare se stessi e l’umanità. L’Inferno propone tutta la gamma dei vizi ma è anche il fondo esistenziale dal quale ripartire per conquistare il Paradiso, la rigenerazione, la salvezza. Nel 1915 il tenente Giuseppe Reina nella trincea del Carso in un diario descrive senza veli la crudezza della guerra, al punto che per due anni la Censura ne proibisce la pubblicazione. Il romanzo-resoconto ha un titolo insolito, Noi che tignemmo il mondo di sanguigno: è il novantesimo verso del Canto V dell’Inferno, la tragedia per amore di Paolo e Francesca. Le aspre alture del Carso si bagnano di sangue. “Da tutto il sangue germinerà un’umanità rinnovata”, nota Reina. Nello stesso luogo intanto un altro soldato scrive versi in trincea. E’ Giuseppe Ungaretti, che pubblicherà nella sua prima raccolta “Il porto sepolto” (1916) gli scarnificati componimenti scritti su margini di giornali, bordi di lettere, cartoline in franchigia.
Anche il tenente Carlo Emilio Gadda tenuto prigioniero dopo la disfatta di Caporetto scrive in baracca, a Celle, un “Giornale di guerra e di prigionia” nel quale annota: “Leggo e rileggo qualche poesia, il che mi riesce di buon sussidio per imparare a ritenere vocaboli”. Ecco, la poesia come grimaldello di conoscenza, chiave del mondo, tanto utile a non perdersi nell’accoramento della prigionia. Cita talvolta Dante, quello della “compagnia malvagia e scempia”. Mentre l’Inferno come un campo di morti è il “CelleLager” per il tenente Niccolò Nicchiarelli che nei suoi versi parla di “otto bolge di fumo”.
Altro anno, altra guerra, altro campo di concentramento. Dal 1943 al 1945 Giovanni Guareschi, tenente di artiglieria catturato dai tedeschi nella caserma di Alessandria, è confinato in una baracca, prima in Polonia, poi in Germania. Redige un “giornale parlato” che si chiama Capanno ed “esce” il sabato alle 20,30. Si fa il giro del campo e si recitano le notizie, così come si tengono discussioni storiche, filosofiche, artistiche, politiche. Compila anche un Diario, che poi distrugge, facendo confluire i ricordi dal lager in “Diario clandestino”, buttato giù alla fine della detenzione. Conserva e pubblica invece Favola di Natale, sogno di libertà inventato durante il confinamento e corredato da icastici disegni. Si affida a Dante nell’introduzione del Diario: “Non abbiamo vissuto come bruti”, che riecheggia l’orazione di Ulisse ai suoi marinai. L’autore di Don Camillo e Peppone chiosa qualche riga dopo: “Fummo peggio che abbandonati, ma questo non bastò a renderci dei bruti: con niente ricostruimmo la nostra civiltà”.