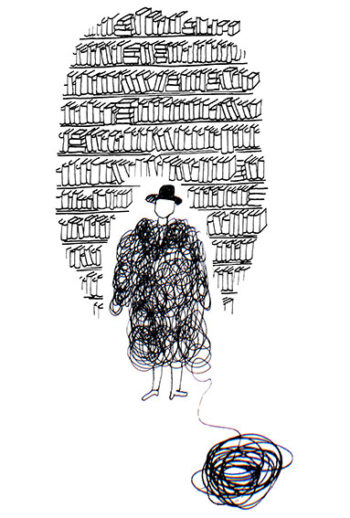I deliri del bibliofilo
Raro e sconfessato
Si tratta di “Resine”, esordio poetico di Camillo Sbarbaro, una raccolta di versi “ruminati” da ragazzo «nelle lunghe passeggiate solitarie». Stampato la prima volta nel 1911, è uno dei libri più ricercati di tutto il ’900. Di quella plaquette il poeta sottolineava «la casualità e l’inconsistenza»
L’importanza sul piano collezionistico è spesso inversamente proporzionale rispetto a quella attestata in campo letterario. Si potrebbero fare parecchi esempi al riguardo, spesso concernenti esordi di autori importanti che si trovarono, per ragioni di vario genere, a sconfessare il contenuto di opere stampate magari a proprie spese. Tanto per fare un nome ci limitiamo a ricordare Vita di Pisto e Cronache dell’Italia meschina di Romano Bilenchi, usciti per Il Selvaggio nel 1931 e per Vallecchi nel 1933. L’autore toscano si pentì presto di queste due prove e, almeno per la prima, si adoperò alacremente «per distruggere tutte le copie che intercetta», come osserva Lucio Gambetti nella sua Storia della letteratura autoprodotta, edita da Luni nel 2022, rendendo conseguentemente il titolo una rarità bibliografica.
 Un caso rilevante in tal senso è quello di Camillo Sbarbaro, uno dei più appartati e, al tempo stesso, significativi poeti italiani del primo Novecento. Si tratta di Resine, esordio poetico dell’autore ligure, stampato nel 1911 dallo Stabilimento d’Arti Grafiche Caimo & C. di Genova. In realtà la figura schiva di Sbarbaro non è adeguatamente rappresentata da questo esile libriccino di 48 pagine, di cm 17 x 12,8, contenente ventidue poesie dal tono adolescenziale e acerbo. Otto di questi testi erano stati anticipati sulle riviste «Pagine Libere» e «La Nuova Lettura», rispettivamente nel 1906 e nel 1908-1909.
Un caso rilevante in tal senso è quello di Camillo Sbarbaro, uno dei più appartati e, al tempo stesso, significativi poeti italiani del primo Novecento. Si tratta di Resine, esordio poetico dell’autore ligure, stampato nel 1911 dallo Stabilimento d’Arti Grafiche Caimo & C. di Genova. In realtà la figura schiva di Sbarbaro non è adeguatamente rappresentata da questo esile libriccino di 48 pagine, di cm 17 x 12,8, contenente ventidue poesie dal tono adolescenziale e acerbo. Otto di questi testi erano stati anticipati sulle riviste «Pagine Libere» e «La Nuova Lettura», rispettivamente nel 1906 e nel 1908-1909.
Il libro venne stampato grazie a una sottoscrizione dei compagni di liceo, tra cui figurava il poeta Angelo Barile. In copertina campeggia un’incisione di Giuseppe Giglioli, tesa a descrivere la poesia inaugurale della raccolta, intitolata Il pino («Si torce il pin rachitico» si legge nell’incipit). La tiratura non è indicata ma deve essere stata estremamente bassa se già nel 1920 Eugenio Montale, recensendo Trucioli, definiva il libretto d’esordio di Sbarbaro praticamente introvabile.
 L’uscita della plaquette procurò al poeta «l’ebbrezza, passando per il Corso, di sbirciare il suo nome bene in vista nella vetrina del maggior libraio». Si tratta di uno dei libri più rari e ricercati di tutto il Novecento, con valutazioni attualmente non disponibili – ma nell’ordine delle migliaia di euro – a causa dell’impossibilità di reperire esemplari messi in vendita. E pensare che la fattura del tipografo fu di 140 lire mentre il ricavo di Sbarbaro ammontò a 16 lire! L’autore rinnegò in seguito la raccolta che provvide a omettere dalle sue Poesie, edite nel 1961 da Vanni Scheiwiller per il marchio All’Insegna del Pesce d’Oro.
L’uscita della plaquette procurò al poeta «l’ebbrezza, passando per il Corso, di sbirciare il suo nome bene in vista nella vetrina del maggior libraio». Si tratta di uno dei libri più rari e ricercati di tutto il Novecento, con valutazioni attualmente non disponibili – ma nell’ordine delle migliaia di euro – a causa dell’impossibilità di reperire esemplari messi in vendita. E pensare che la fattura del tipografo fu di 140 lire mentre il ricavo di Sbarbaro ammontò a 16 lire! L’autore rinnegò in seguito la raccolta che provvide a omettere dalle sue Poesie, edite nel 1961 da Vanni Scheiwiller per il marchio All’Insegna del Pesce d’Oro.
D’altro canto già i successivi titoli Pianissimo e Trucioli, editi rispettivamente dalla Libreria della Voce nel 1914 e da Vallecchi nel 1920, non sono facili da reperire sul mercato antiquario (in Rarità bibliografiche del Novecento italiano di Gambetti e Vezzosi è riportata una scheda relativa a un manufatto dattiloscritto curato dall’autore nel 1914 di Trucioli, rilegato in pelle, di 204 pagine, rarissimo e senza quotazioni disponibili, che fa idealmente da pendant con un’autoedizione di Sottovoce, titolo originario di Pianissimo, stampata nel 1942 in pochissimi esemplari numerati). È nota l’acribia con la quale Sbarbaro lavorava ai propri testi, modificandoli in continuazione. Di entrambi i titoli verranno licenziate altre edizioni con significative varianti: le prose di Trucioli usciranno nello “Specchio” mondadoriano nel 1948 mentre Pianissimo conoscerà un controverso rifacimento allestito dall’autore per la collana “Poesia” di Neri Pozza nel 1954.
 È significativo d’altronde che la raccolta Resine sia recuperata in toto nella recente edizione delle Poesie e prose, il “Meridiano” curato da Giampiero Costa, con una densa introduzione di Enrico Testa. A ben vedere la raccolta era stata riproposta nella collana “Opera prima” di Garzanti, curata da Enrico Falqui, nel 1948. Si tratta del nono volumetto della collana, di 46 pagine, con due tavole riproducenti la copertina dell’edizione originale e una foto giovanile di Sbarbaro. La tiratura è limitata a 200 esemplari numerati, stampati su carta a mano pesante vergata “Leonardo”, oltre ai 15 riservati al servizio stampa, impressi su carta comune (vedi al riguardo il volumetto Opera prima. Garzanti 1947-1948, curato da Massimo Gatta per le Edizioni SO nel 2022). Scrive l’autore in una nota apparsa in calce a questa riproposta editoriale: «Mi ha indotto a ristampare questo mio primo libretto il programma della collezione e l’insistenza dell’amico Falqui. Al ricevere delle bozze, mi coprii la faccia dalla vergogna: mancando da anni del testo, mi ritrovavo sott’occhio, irrefutabili, insieme ad altre che ricordavo, cose che non sapevo più d’aver scritto. Questi versi risalgono al tempo del ginnasio e della prima liceo. Non li scrivevo: li ruminavo nelle lunghe passeggiate solitarie che da ragazzo avevo l’abitudine di fare. […] Furono i miei compagni di liceo, per iniziativa di Angelo Barile, a pubblicarli a loro spese. Fu pure Angelo Barile a dare il titolo. Il mio, era Fuochi fatui che dei versi voleva denunciare la casualità e l’inconsistenza».
È significativo d’altronde che la raccolta Resine sia recuperata in toto nella recente edizione delle Poesie e prose, il “Meridiano” curato da Giampiero Costa, con una densa introduzione di Enrico Testa. A ben vedere la raccolta era stata riproposta nella collana “Opera prima” di Garzanti, curata da Enrico Falqui, nel 1948. Si tratta del nono volumetto della collana, di 46 pagine, con due tavole riproducenti la copertina dell’edizione originale e una foto giovanile di Sbarbaro. La tiratura è limitata a 200 esemplari numerati, stampati su carta a mano pesante vergata “Leonardo”, oltre ai 15 riservati al servizio stampa, impressi su carta comune (vedi al riguardo il volumetto Opera prima. Garzanti 1947-1948, curato da Massimo Gatta per le Edizioni SO nel 2022). Scrive l’autore in una nota apparsa in calce a questa riproposta editoriale: «Mi ha indotto a ristampare questo mio primo libretto il programma della collezione e l’insistenza dell’amico Falqui. Al ricevere delle bozze, mi coprii la faccia dalla vergogna: mancando da anni del testo, mi ritrovavo sott’occhio, irrefutabili, insieme ad altre che ricordavo, cose che non sapevo più d’aver scritto. Questi versi risalgono al tempo del ginnasio e della prima liceo. Non li scrivevo: li ruminavo nelle lunghe passeggiate solitarie che da ragazzo avevo l’abitudine di fare. […] Furono i miei compagni di liceo, per iniziativa di Angelo Barile, a pubblicarli a loro spese. Fu pure Angelo Barile a dare il titolo. Il mio, era Fuochi fatui che dei versi voleva denunciare la casualità e l’inconsistenza».
 Ma il poeta (nella foto) asserì nel 1954, riguardo al titolo: «Il mio era più modesto e, per quel che ancora mi pare, più appropriato: Bolle di sapone». Angelo Barile confermò tale versione: «Vedo ancora sulla copertina di Resine (fui io a volere quel titolo: l’autore avrebbe preferito Bolle di sapone), il pino squassato dal vento piangere dalle sue ferite». Nelle note allestite per il “Meridiano” viene riportato che, nelle testimonianze relative al volumetto edito nel 1911, figuravano entrambi i titoli: com’era nelle abitudini di Sbarbaro, saranno recuperati in due volumetti scheiwilleriani, rispettivamente del 1956 e del 1966. Con la consueta ironia, nella succitata nota della ristampa garzantiana, l’autore osserva: «In un paese dove qualche volta càpito incontro immancabilmente un antico compagno di scuola, che immancabilmente mi rinfaccia d’averlo privato di Resine, l’unico mio testo valido, per sostituirlo con altro di nessun valore. Una frode dunque o poco meno. La ristampa dà modo di riparare alla malefatta. A così buon prezzo potessi saldare tutti i miei debiti prima di andarmene».
Ma il poeta (nella foto) asserì nel 1954, riguardo al titolo: «Il mio era più modesto e, per quel che ancora mi pare, più appropriato: Bolle di sapone». Angelo Barile confermò tale versione: «Vedo ancora sulla copertina di Resine (fui io a volere quel titolo: l’autore avrebbe preferito Bolle di sapone), il pino squassato dal vento piangere dalle sue ferite». Nelle note allestite per il “Meridiano” viene riportato che, nelle testimonianze relative al volumetto edito nel 1911, figuravano entrambi i titoli: com’era nelle abitudini di Sbarbaro, saranno recuperati in due volumetti scheiwilleriani, rispettivamente del 1956 e del 1966. Con la consueta ironia, nella succitata nota della ristampa garzantiana, l’autore osserva: «In un paese dove qualche volta càpito incontro immancabilmente un antico compagno di scuola, che immancabilmente mi rinfaccia d’averlo privato di Resine, l’unico mio testo valido, per sostituirlo con altro di nessun valore. Una frode dunque o poco meno. La ristampa dà modo di riparare alla malefatta. A così buon prezzo potessi saldare tutti i miei debiti prima di andarmene».