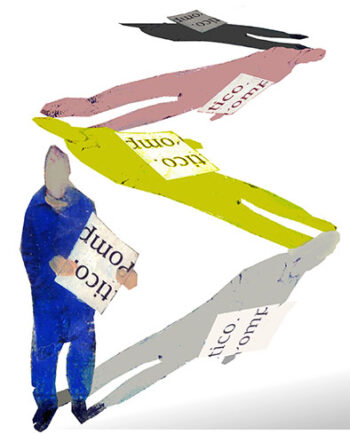“La volpe dentro” di Eva Taylor
L’interspazio di Eva
La nuova raccolta dell'autrice di lingua madre tedesca che scrive anche in italiano. La sua poesia sembra semplice, a volte giocosa, ma in realtà è attraversata da una pena immedicabile. Con un tema ricorrente, quello della casa, delle proprie radici
«Io vivo con due bocche / e parlo con tre lingue». Così Eva Taylor nella sua prima raccolta poetica in italiano (L’igiene della bocca, l’Obliquo, 2006). E due sono i suoi nomi: un nom de plume che altro non è se non il cognome inglese acquisito, e il nome di nascita di cui si avvale nell’attività di docente e di studiosa nel campo della sociolinguistica, che non ritengo ora necessario rivelare, ma che trapela, in un senhalneppure troppo nascosto, nell’ultima raccolta edita, La volpe dentro(MC, 2023). Delle tre lingue, la meno legata a una sfera soggettiva è senza dubbio l’inglese, usato per scopi professionali e in ambito, presumibilmente, domestico. Il tedesco è invece la lingua materna, irrinunciabile e contraddittoria, la lingua che porta dentro di sé il marchio indelebile dell’origine insieme allo stigma doloroso della storia. Lingua della tragedia collettiva di un popolo e di una nazione, e al tempo stesso quella di una famiglia proveniente da un paese della Turingia, oppressa da due dittature consecutive, che poco prima della costruzione del muro riesce a fuggire all’Ovest, forse a bordo di una vacillante Trabant, senza più nulla, lasciandosi alle spalle parenti e amici, con una figlia ancora piccola che poi racconterà questa storia personale e comune in un romanzo (Carta da zucchero, Fernandel, 2015). E infine l’italiano, incontrato per opera del caso o del destino e sentito come la lingua della riparazione e del rinnovamento, non scelta ma ricevuta quasi fosse un dono, appresa sui libri e nelle aule, ma più ancora dal quotidiano rapporto con la gente, tanto da diventare nel corso degli anni non più soltanto una seconda lingua, ma qualcosa di molto più profondo. In un articolo che possiamo ben considerare una dichiarazione di poetica, Eva Taylor sostiene infatti che «nella lingua non materna c’è un maggiore effetto di straniamento» (Perché ci vogliono due lingue per scrivere una poesia?, in «reCHERches», n. 10 / 2013), così che l’italiano si mostra a lei tanto più efficace e attraente quanto più resta in esso un’ombra di mistero, di inespresso o di non interamente compreso, ovvero quel margine di indeterminatezza che è poi la cifra distintiva della sua poesia.
 La complessa esperienza della lingua è dunque il filo che unisce le tre sezioni del libro. Quella d’apertura, intitolata Benvenuta nel Bel Paese, è il frammentario resoconto del primo impatto con i nuovi parlanti italiani, rispetto ai quali l’attonito senso di smarrimento appare però mitigato da una vena di ironia, innanzitutto nei confronti di se stessa. Può così ricordare non più con fastidio ma con bonaria condiscendenza l’eloquio stereotipato di coloro che le si rivolgevano con un improbabile e derisorio tedesco, simile a quello escogitato da Bonvi per le Sturmtruppen. Anche in questo modo può comunque verificarsi il travaso da un lessico in un altro, di una sintassi in un’altra, mentre con sempre maggiore incidenza si costituisce quel fragile equilibrio tra «una lingua che diventa lontana / e un’altra a tratti vicina» (Il sogno di Rebecca, p. 27). E tuttavia, anche quando una stessa poesia viene composta nelle due lingue, la pratica di autotraduzione non consiste soltanto nel passaggio da un codice a un altro perché, come osserva Eva Taylor nell’articolo segnalato poc’anzi, «chi scrive entra in un interspazio che porta a un costante cambiamento di prospettiva».
La complessa esperienza della lingua è dunque il filo che unisce le tre sezioni del libro. Quella d’apertura, intitolata Benvenuta nel Bel Paese, è il frammentario resoconto del primo impatto con i nuovi parlanti italiani, rispetto ai quali l’attonito senso di smarrimento appare però mitigato da una vena di ironia, innanzitutto nei confronti di se stessa. Può così ricordare non più con fastidio ma con bonaria condiscendenza l’eloquio stereotipato di coloro che le si rivolgevano con un improbabile e derisorio tedesco, simile a quello escogitato da Bonvi per le Sturmtruppen. Anche in questo modo può comunque verificarsi il travaso da un lessico in un altro, di una sintassi in un’altra, mentre con sempre maggiore incidenza si costituisce quel fragile equilibrio tra «una lingua che diventa lontana / e un’altra a tratti vicina» (Il sogno di Rebecca, p. 27). E tuttavia, anche quando una stessa poesia viene composta nelle due lingue, la pratica di autotraduzione non consiste soltanto nel passaggio da un codice a un altro perché, come osserva Eva Taylor nell’articolo segnalato poc’anzi, «chi scrive entra in un interspazio che porta a un costante cambiamento di prospettiva».
È quanto accade nella seconda sezione Cartoline illustrate che accoglie, accanto a scorci non consueti di Venezia e Firenze, la serie ferroviaria Nella Pianura Padana, con nomi di stazioni appena intraviste dal finestrino di un treno. Prima di questa versione italiana le sei poesie furono pubblicate in tedesco (San Marco Handpresse, 2013), poi in entrambe le lingue sulla rivista «Filigrane» (II, 1 – 2021). Il testo italiano acquista però un senso amplificato proprio grazie al succitato effetto straniante e ai calembour offerti da una toponomastica allusiva:«Herzen erkranken / si ammala di cuore» (Crevalcuore, con grafia di proposito modificata, a p. 39), «wie ein Nussbaum / come un noce»(Nogara, p. 42), «schlechten Herberge / debole albergo» (Malalbergo, p. 43).
La terza e ultima parte si configura come un bestiario disposto in ordine alfabetico. Nel descrivere le varie specie di quelli che ella definisce«animali vaganti» – molluschi, pesci, insetti, piccoli e grandi mammiferi – l’autrice tenta «di scorgere nelle loro esistenze precarie un’analogia con le nostre, oppure di sentire nella loro muta presenza qualcosa che ci colpisce e ci interroga», osserva Marco Molinari nella sua densa prefazione. Poesia dunque solo in apparenza semplice, quasi naive, talora persino giocosa, ma attraversata in realtà da una pena oscura, venata di un’angoscia immedicabile. E forse è proprio questo il significato da attribuire alle «due bocche», come ci induce a ipotizzare la stessa Taylor. Indicazione fornita anche dal titolo della sezione: anagrammando infatti l’infantile espressione Animaliconla si ottiene, e non certo per caso, «la malinconia». Una simile percezione di svuotamento, di muto dolore, può provenire tanto da uno stato d’animo individuale quanto da una memoria: «Porto anch’io una macchia / Qualcosa di passato» (Pettirosso, p. 78). A volte è però la storia che irrompe con violenza nel dettato poetico: quando si legge di una rara razza equina che «fu oggetto di esperimenti genetici / anche da parte dei nazisti» (Konik, p. 71) non si può non pensare all’orrore di analoghi interventi compiuti in quegli anni sciagurati su cavie umane; o quando viene ricordato il pittore ebreo tedesco Frank Auerbach (Lince, p. 72), inviato ancora bambino in Inghilterra per sfuggire all’internamento mediante un piano di Kindertransport (di cui l’autrice si è occupata in veste di studiosa). Animali emblematici insomma, tra i quali spicca naturalmente la volpe del titolo, colta mentre appare all’improvviso e subito fugge nel folto del bosco, come nella consolidata tradizione favolistica poi ripresa, tra gli altri, dal qui citato Janáček in un’opera musicale che «mi risuonava dentro» (p. 88), quasi come la voce stessa della poesia.
 L’attenzione è però ancora rivolta alla lingua, «una lingua inciampata» (p. 89) di cui Eva (nella foto) avverte, mentre la esplora, l’incanto di nuovi ritmi, di accostamenti bizzarri, di inattese assonanze, perché, ella afferma «le mie parole in italiano nascono da un piacere delle parole». Così vediamo Elefante rimare con «elegante» e «olifante» (pp. 62-63), e Upupa con «pupa» (p. 87); o, già all’inizio, l’ambigua omofonia di Stufa, nome e aggettivo (p. 19). La lingua entra nel mondo naturale e la natura diviene una sorta di specchio del linguaggio, all’interno del quale scavare per ritrovare una qualche recondita corrispondenza. Ecco dunque «una lingua volata» delle Farfalle (p. 64), o «dalle lettere uscire le formiche / portare via il senso» (p. 66), e «se fossi una parola / sarei scoiattolo – / su e giù nel cavo orale / le vocali come appoggio» (p. 83).
L’attenzione è però ancora rivolta alla lingua, «una lingua inciampata» (p. 89) di cui Eva (nella foto) avverte, mentre la esplora, l’incanto di nuovi ritmi, di accostamenti bizzarri, di inattese assonanze, perché, ella afferma «le mie parole in italiano nascono da un piacere delle parole». Così vediamo Elefante rimare con «elegante» e «olifante» (pp. 62-63), e Upupa con «pupa» (p. 87); o, già all’inizio, l’ambigua omofonia di Stufa, nome e aggettivo (p. 19). La lingua entra nel mondo naturale e la natura diviene una sorta di specchio del linguaggio, all’interno del quale scavare per ritrovare una qualche recondita corrispondenza. Ecco dunque «una lingua volata» delle Farfalle (p. 64), o «dalle lettere uscire le formiche / portare via il senso» (p. 66), e «se fossi una parola / sarei scoiattolo – / su e giù nel cavo orale / le vocali come appoggio» (p. 83).
L’esito raggiunto è quello di una poesia del tutto lontana dalla declamazione, in cui il registro quotidiano, a tratti anche umoristico, si alterna con una gravità di tono e di immagini che può richiamare la crudezza di Gottfried Benn o l’oscurità franta di Celan, dal quale d’altronde nessun poeta tedesco credo possa ancor oggi prescindere. Piuttosto a me vengono alla mente certi brevi testi di Paul Klee, tracciati come sottili e rarefatte miniature. Anche in Eva Taylor è riscontrabile una simile tendenza all’essenzialità, punto d’arrivo di una riscrittura a cui ella attribuisce un’importanza fondamentale, che viene confermata da un procedimento correttorio orientato verso tale direzione.
Ma c’è in fondo un tema ricorrente, quasi ossessivo, che attraversa l’intera raccolta, ovvero quello della casa, irrimediabilmente perduta e rievocata non più che come assenza e memoria. Del resto, il libro precedente a questo si chiama proprio Lezioni di casa (Arcipelago Itaca, 2019). In esso, a proposito di riscrittura, ritroviamo una versione anteriore, o comunque diversa, della poesia Fachwerkhaus (in La volpe dentro a p. 31), l’avita casa a graticcio delle proprie radici, la cui esistenza è ormai solo attestata da una fotografia in bianco e nero. La vana ricerca di un luogo o l’impossibile ritorno a esso è dunque il nodo cruciale della poesia di Eva Taylor, il suo assillo, la sua più autentica e riposta ispirazione. E tale si invera nel vicolo fuori mano dove «vengo a volte per sentirmi a casa / a vedere una casa mai avuta» (Firenze, Via del Ronco, p. 44); o nel comportamento del piccolo crostaceo (Pagurus Bernhardus, p. 77) assurto a valore di simbolo: «E come un paguro / ho cercato un terreno / un angolo, una casa / per proteggere / questa striscia scarsa, / questo me eremita / di cui ho bisogno / per essere qui».