A proposito di "Quintetto romano"
Cinque maschere romane
Raoul Precht ha raccontato Roma inventando cinque storie alla maniera di cinque narratori diversissimi tra loro: Stendhal, Nikolaj Gogol, Romain Rolland, Malcom Lowry e John Cheever
Si può scrivere un romanzo mettendo insieme cinque racconti? E, se è possibile, come fanno a convivere insieme la “forma breve” del racconto con quella più lunga e strutturata del romanzo? Un racconto si dice tale quando non supera le 30 cartelle, e la scrittura sottende una istanza di comunicazione verso il lettore, (possiamo anche parlare di una oralità di fondo), mentre il romanzo non ha limiti nella sua lunghezza ma soprattutto cerca di ricreare sulla carta un “mondo” intangibile, costruito attraverso una polifonia di voci amalgamate fra loro. Sembra un ossimoro scrivere come sottotitolo “romanzo in cinque racconti”, come fa Raoul Precht con il suo nuovo libro, Quintetto romano, Bordeaux, 260 pagine, 18 Euro. Infatti, possiamo dire che fra racconto e romanzo vi è la stessa differenza che può esistere fra una canzone e l’opera lirica, dove per canzone si intende un brano musicale breve, mentre per opera lirica una vasta rappresentazione scenica a carattere drammatico.
Se il sottotitolo ci lascia perplessi, il titolo del “romanzo”, Quintetto romano, ci riempie di stupore, quindi per superare il quale faremo riferimento ancora alla musica. La quale ricorda che nella musica da camera esistono sia il quartetto che il quintetto, quattro o cinque strumenti che suonano insieme. Strumenti diversi vogliono spartiti diversi, ma soprattutto persone diverse che abbiano la capacità di percorrere la stessa strada sonora. Se il titolo ed il sottotitolo ci hanno confuso le idee, forse l’indice ci può aiutare a diradare la nebbia della comprensione. Infatti, vediamo che vi sono cinque autori i quali hanno in comune il medesimo tema, la città di Roma. Si tratta di Stendhal, Nikolaj Gogol, Romain Rolland, Malcom Lowry e John Cheever, che hanno visitato la città eterna nell’arco di un poco più di un secolo, dal 1823 al 1956.
A questo punto, lo sconcertato lettore trae subito una conclusione: il libro non sarebbe altro che una antologia di cinque racconti, scritti da cinque autori diversi sulla città. Ed egli già intravede la stanza nella penombra, il divano sul quale sdraiarsi, il bastoncino d’incenso e il fiume di parole che i suoi occhi andranno a percorrere, dicendo, “bene, vediamo come due francesi, un americano, un inglese ed un russo hanno raccontato la città capitale”.
Giunto alla fine della lettura, lo sconcertato lettore viene a sapere che non si tratta di una antologia di cinque autori diversi ma al contrario di un solo autore che ha imitato lo stile di cinque scrittori diversi per raccontare la città di Roma. Insomma, il quintetto è composto da un solo artista che prima suona uno strumento, poi passa ad un altro e via via fino alla fine. Insomma, ci troviamo di fronte a cinque falsi d’autore.
Ed allora viene da chiedersi perché Raoul Precht ha usato cinque maschere diverse per raccontare la città che ama?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricordare le “passeggiate romane” di Stendhal, ossia quel genere letterario in gran voga nell’Ottocento, il viaggio in Italia del Grand Tour, quando uno scrittore straniero raccontava, usando la penna, ai suoi connazionali le meraviglie dei luoghi visitati.
In questo caso, l’autore sembra voler rinnovare o parodiare il genere. L’unico modo per farlo è fingersi straniero, cercando di vedere le cose con uno “sguardo vintage” come le hanno viste i viaggiatori citati nell’arco di un secolo, insomma scrivere alla maniera di…Un falso d’autore, perché il vero falsario non è un uomo sprovveduto che non conosce l’oggetto che va ad imitare, anzi è uno specialista che grazie a questa competenza può rivaleggiare con l’autore.
Nel primo racconto, il nostro Stendhal scrive una lettera (apocrifa) alla sua amica Clémentine Curial, raccontando la sua promenade per la città. Ragguaglia circa il carattere “passionale e selvaggio” dei trasteverini, sull’uso del coltello nelle dispute (ed a questo punto come non ricordare il film Camera con vista di James Ivory tratto dal romanzo a Forster, che non si svolge a Roma bensì a Firenze?), critica la musica “grossolana” suonata in città, riporta le discussioni sull’opportunità di scrivere tragedie in versi o in prosa, accenna alla presenza della “carboneria”, tutti temi legati agli anni iniziali del XIX secolo. Ma soprattutto non trascura di parlare delle rovine, tema costante della letteratura del Grand Tour. In questo caso non si tratta dei monumenti della classicità romana, bensì quelle causate dagli uomini. Racconta alla sua cara amica dello sciagurato incendio della Basilica di San Paolo fuori le mura, la seconda Basilica della cristianità, avvenuto nel luglio del 1823.La domanda che (lo pseudo) Stendhal rivolge al destinatario della lettera che può essere la sua amica oppure il lettore stesso, è quella che la storia non ha mai chiarito: fu un’incuria degli stagnari che lavoravano nell’edificio oppure una iniziativa doloso di alcuni mangiapreti, fra i queai si intuiscono essere i carbonari? Un incendio, comunque, che distrusse “capolavori assoluti ed irripetibili”.
La lettera ricostruisce molto bene l’ambiente dei salotti romani, ma soprattutto quella pratica della conversazione, il “filosofare” fra gentiluomini, che ha le caratteristiche di un vero e proprio genere letterario. Una pratica costante fra gli “spiriti eletti” del Grand Tour, utile a dimostrare di aver conosciuto persone di rilievo e di far parte di quell’intellighenzia europea che vive al di sopra dei confini delle nazioni.
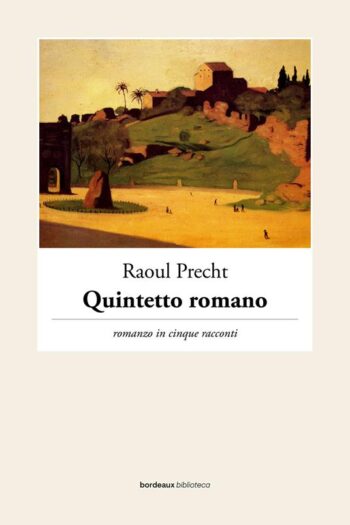 Se Stendhal visita i salotti della nobiltà, il generone, il secondo racconto ci propone la migliore Roma popolare, quella delle taverne e della poesia del Belli. A raccontarla è lo scrittore delle “anime morte” Nikolaj Gogol che perlustra con passione le strade dei quartieri inseguendo voci ed odori. Dopo più di un anno di permanenza è divenuto ospite fisso del Caffè Greco, dove servono un caffè con una deliziosa panna e le taverne dove mangia “le migliori prelibatezze, i manicaretti e le bevande che l’oste selezionava attentamente”. Girando per le strade assiste alle risse verbali fra due barrocciai, ammira il lavoro delle lavandaie, la bellezza del Pantheon, l’elefantino della Minerva ma soprattutto visita religiosamente l’osteria del Falcone. Le pagine del libro che descrivono il pranzo a base di maccheroni cacio e pepe, che vanno da pagina 80 fino a 85, meritano di essere lette con passione, perché sono capaci di ricreare quelle atmosfere tipicamente romane, molto cara alla poesia dell’oscuro poeta, il Belli. Che conosce di persona, sentendolo recitare “davanti alla platea gremita e silenziosa” i suoi sonetti che riguardavano usi e costumi della città. Pur non avendo capito tutte le parole, alla fine Gogol sentenzio che i sonetti sono “delle vere e proprie gemme”. Anzi, non si semplici sonetti si tratta ma di un vero e proprio poema.
Se Stendhal visita i salotti della nobiltà, il generone, il secondo racconto ci propone la migliore Roma popolare, quella delle taverne e della poesia del Belli. A raccontarla è lo scrittore delle “anime morte” Nikolaj Gogol che perlustra con passione le strade dei quartieri inseguendo voci ed odori. Dopo più di un anno di permanenza è divenuto ospite fisso del Caffè Greco, dove servono un caffè con una deliziosa panna e le taverne dove mangia “le migliori prelibatezze, i manicaretti e le bevande che l’oste selezionava attentamente”. Girando per le strade assiste alle risse verbali fra due barrocciai, ammira il lavoro delle lavandaie, la bellezza del Pantheon, l’elefantino della Minerva ma soprattutto visita religiosamente l’osteria del Falcone. Le pagine del libro che descrivono il pranzo a base di maccheroni cacio e pepe, che vanno da pagina 80 fino a 85, meritano di essere lette con passione, perché sono capaci di ricreare quelle atmosfere tipicamente romane, molto cara alla poesia dell’oscuro poeta, il Belli. Che conosce di persona, sentendolo recitare “davanti alla platea gremita e silenziosa” i suoi sonetti che riguardavano usi e costumi della città. Pur non avendo capito tutte le parole, alla fine Gogol sentenzio che i sonetti sono “delle vere e proprie gemme”. Anzi, non si semplici sonetti si tratta ma di un vero e proprio poema.
La Roma di Romain Rolland è quella di fine secolo, la città decadente che conosciamo attraverso il romanzo Il piacere di D’Annunzio, con il quale il francese non entra in contatto. Anzi, visita la città, dove vivrà per due anni a Palazzo Farnese con una borsa di studio dell’Ambasciata francese, facendo continui paragoni mentali con Parigi. “Passeggiata su Via del Corso. Marciapiedi minuscoli, strettissimi. Altro che Champs-Elysées, come vorrebbero farti credere. Però non è male. Sempre affollata, questa benedetta strada. La gente vuole vedere e farsi vedere”. Rolland attraversa la città cercando spartiti ed ascoltando orchestre, inseguendo il mondo della musica, il linguaggio universale capace di accomunare tutti gli uomini. Poche sono le cose che ammira, pertanto non lesina giudizi negativi sulla musica italiana, sulle rovine antiche, sul clero e sulla politica. E’ più interessato alla campagna romana che alla città vera e propria: “aveva ragione Poussin. La potenza della pianura”. Roma gli appare meravigliosa solo di notte. “Pomeriggi sempre più caldi, ma serate squisite. Arietta proveniente dal mare fino alle cinque del pomeriggio. Notti meravigliose, limpide, in cui ci si rende conto del proprio respiro”.
Con il racconto di Malcolm Lowry, conosciamo la città del dopoguerra, che si rialza a fatica dalle distruzioni della guerra. Ma lo scrittore inglese sembra più interessato ai bicchieri di grappa che servono nei bar oppure al vino dei castelli, ed alle case degli scrittori stranieri che hanno abitato la città, anziché alla nascita del neorealismo cinematografico o ai capolavori custoditi nei musei ed alle rovine antiche. Fra lui ed il mondo vi è l’alcool più che la letteratura. Quindi, ora che è famoso, a causa del successo del romanzo Sotto il vulcano può finalmente essere se stesso: “ Posso insomma cedere al mio vero talento, che prevede uno stato di ubriachezza costante interrotto da qualche infelice momento di semilucidità”. L’attraversamento della città è un vero e proprio pellegrinaggio etilico, condizione che gli permette di fare delle allucinate e geniali considerazioni: “Eppure, soprattutto quando siamo in viaggio e non si riesce comunque a lavorare, il tempo per noi non è poi così decisivo come ho detto varie volte a Marg, in fondo il tempo non è che quella cosa che impedisce agli eventi di accadere simultaneamente, una specie di vigile urbano che governa il traffico del mondo e mette ordine. Se non ci fosse il tempo il mondo sarebbe un caos invivibile…”. L’ubriachezza come difesa dal mondo, che ti aggredisce con le sue insondabili meraviglie ed i suoi prolifici orrori.
Il racconto di Cheever inizia con una scena fulminante. Lo scrittore sta cercando di seppellire il corpicino di Barbara Frietchie che non è una bambina ma una topolina bianca a Villa Borghese. Divenuta la mascotte della famiglia dopo essersi esibita in un piccolo circo nel Connecticut. Giace nella tasca del cappotto, poiché siamo a dicembre, all’interno di una scatola di caramelle, foderata con un mazzo di violette. Prima di abbandonarla alla terra lo scrittore si siede su una panchina e riflette sul cucchiaio che si è portato da casa per scavare la terra ma soprattutto sui problemi della lingua di Dante, la gestualità dei romani, gli innamorati che si baciano in pubblico, sulla bottiglia di gin nascosta nello stanzino delle scope….
Cheever, l’autore del celebre racconto Il nuotatore, dove si racconta di un uomo che per tornare a casa sceglie di nuotare in tutte le piscine che incontra, a Roma ingaggia un corpo a corpo con la città nel quale non si capisce chi ne uscirà vincitore.
L’autore di questo “romanzo in cinque racconti” che dimostra una vigorosa capacità di travestimento narrativo e grande cultura letteraria, alla fine del libro ci lascia ancora con la domanda che ci siamo posti all’inizio: perché chiamare romanzo una serie di racconti scritti alla maniera di…Per via della finzione oppure perché la parola “romanzo” deriva dal francese antico romant, che a sua volta deriverebbe dal latino volgare, romanice che significa “parlare latino” ossia parlare come si usa nella città di Roma? Se è così, il romanzo coincide con il tema della narrazione, e siccome l’autore è nato nella stessa città di cui scrive, allora tutto diventa chiaro: l’autore è una guida turistica che organizza percorsi letterari per un pubblico ignaro della letteratura scritta dai visitatori della città eterna. Alla fine della passeggiata i turisti possono ringraziare la guida comprando il libro dove sono riunite tutte le cose che ha raccontato.
La fotografia accanto al titolo è di Roberto Cavallini.

