Le poesie di “Ablativo assoluto”
All’origine di Carifi
La recente raccolta del poeta toscano è «una delle soglie più desolate ed esigenti» della sua opera. Versi «salati, scarni, deposti». Ma resta nella sua poetica la “semi-luce” del sacro, quella per cui il monaco «prega/ e piange per le cose del mondo»
Il recente libro di poesia di Roberto Carifi, Ablativo assoluto (Editore Animamundi, una piccola preziosa editrice con sede a Otranto, 120 pagine, 13 euro), ci giunge come un dono, vivendo il poeta un rigido inverno, calato «in fondo a cantine buie/ dove fa freddo, febbre, febbre,/ nella muta piramide dei corpi». Una fragilità la sua che disegna le giornate, con il cielo ridotto a una finestra, ecco allora che il poeta invoca, con una incrinata preghiera, che cessi il furore del male e che il monaco interceda affinché «i serpenti/ che succhiano la mia gamba/ ed il braccio ammalato/ tu che sei nell’abisso/ poni fine a queste mie disgrazie». Lo scrittore toscano ancora una volta ci presenta una poesia “nutrita” da un pensiero disarmato e come egli stesso ebbe modo di dire, poeta «è chi nel combattimento, si inginocchia al momento giusto». Carifi non cincischia mai con le parole, neppure si “arrangia” attraverso un facile manierismo, piuttosto si avverte come l’urgenza sia il “sangue” di una poesia che è sicuramente tra le più decisive e profonde della scena poetica contemporanea.

Con intensa partecipazione nella prefazione Benedetta Silj afferma che Ablativo assoluto è «una delle soglie più desolate ed esigenti dell’opera di Carifi, i versi si offrono qui salati, scarni, deposti». Il pubblico attento e fedele ai suoi desolati versi, percepisce come egli tenda alla “spoliazione” di sé, assumendo quella radicalità e quella manifesta verità che è l’esistenza stessa della poesia. Carifi è del 1948 e i libri da lui scritti sono tanti, si va dalla poesia alla filosofia, dal racconto al teatro, dalla traduzione alla critica, e anche per chi conosce la sua opera, infine diviene complicato raccontarla compiutamente. Ablativo assoluto rimane comunque un libro che si pone nel solco del suo percorso poetico, con alcuni temi che ritornano, essendo i punti cruciali della propria esistenza. Sintetizzando: l’infanzia difficile, la solitudine, la morte della madre, la tensione mistica (cristiana e buddista), infine la malattia.
L’infanzia di Carifi fu segnata da disagi e da dolori, in particolare dovuti dall’abbandono del padre, un incrocio nevralgico che rappresentò per il poeta un’amara condanna affettiva. Parliamo quindi di una casa deserta, di una lacerazione ampia e difficilmente sopportabile: «Certe notti, durante l’infanzia,/ mi svegliava il gemito dei cani/ impazziti di freddo e di fame,/ inizierò così, dalla mia veglia,/ da questa anonima miseria». La desolazione dell’abitazione di montagna realmente vissuta da Carifi, non è solo il “marmato” giaciglio, bensì è da intendere (ricordando anche la casa Usher di Poe), come la cifra destinale, come la condizione di angoscia che la vita, volendo interpretare il pensiero del poeta, riserva a ognuno di noi. Ma il suo fu di certo “vivere” in un baratro, in un orrore che ne marcò l’esistenza. L’inizio, l’origine, è in nuce in questo titolo, appunto “ablativo assoluto”, ed è un lastricato di pene, ma poi vi è la constatazione del poeta che dice che tra l’inizio e la fine non c’è pausa e tutto si sintetizza in un’amara conclusione: «nascita e morte si equivalgono/ cordigliere da cui la vita/ non è che un ammasso di fiori abbandonati».
E la neve di quella montagna, che Carifi ricorda come viva afflizione, diviene solo «neve insanguinata», e «le facce in fondo alle pozze» sono l’arredo delle proprie giornate. Versi che riecheggiano pesanti, come i battiti di una campana feroce che diviene puro abisso, in cui vi è «un lumicino accanto al tuo ritratto,/ piangeresti se non fosse arato/ da un amore più forte». Chiaro di chi sia quell’amore più forte: della madre. Quella donna raccolta nel sudario di difficili anni. E quel sopravvivere assieme, quel sorreggersi reciprocamente, anche lei esiliata dalla vita, è l’immagine dei tanti giorni raccolti in una piccola casa, proprio là dove «gli sciatori/ in quella camera abbandonata» il poeta occhieggiava. Poi c’è il ricordo dei ricordi, il giorno marino nella deriva assoluta, quando: «Andammo insieme al mare,/ al Forte dei Marmi,/ lei con un cappellino a fiori,/ felice come non era stata mai,/ faceva sfoggio di sottane/ dai mille colori, collanine di perle./ Era vicino il giorno che sarebbe/ uscita per sempre dalla vita».
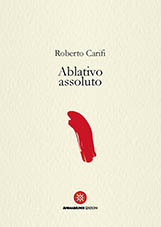
Carifi ha intriso i suoi versi non solo di amara memoria, da sempre vi è pure la “semi luce” del sacro, un misticismo dolente, sia che guardi a Cristo o a Budda. Egli implora la Croce, perché nel suo guardare il legno santo (scriveva: «La Croce è un evento inaccessibile a ogni attesa e ad ogni previsione umana, nel volto sfigurato dall’agonia il Figlio mostra la carità estatica del Padre»), vede il segno del dolore e della speranza, e ritornando su quella ferita iniziale (che poi, come è stato detto, proprio da certe piaghe, nasce la spinta alla scrittura), sa che «Cristo ha i caratteri della condizione filiale a cominciare dall’abbandono, dall’erranza, dall’esilio». Quello del raccoglimento e del vivere nel sacro, che non è quindi la pasoliniana “nostalgia sacra”, è il percorso da compiere quotidianamente: «Dirò in solitudine le preghiere/ a nord di tutte le terre, di tutte le nevi/ vestito con un paio di pantaloni arancione/ reciterò a voce bassa,/ quasi impercettibile,/ le ruote dell’illuminato».
Il suo lottare verso una pacificazione interiore è attraversato da una spiritualità sofferta, immersa in una evidente quotidiana ferita. Tuttavia, proprio da quel tormento e «lasciando la morte e la vita/ oltrepassando l’abisso di nessuno», ci si può avvicinare al Signore. Ecco, Carifi sa che risacralizzare, dando slancio per quanto possibile alla speranza, è «dare l’impronta del sacro e del santo alle cose e alle creature», è seguire «le ruote dell’illuminato», è tentare di tracciare un solco nella nostra precaria presenza terrena, come fa il monaco «che prega/ e piange per le cose del mondo».
Vicino al titolo, l’immagine di un particolare del “Ritorno dal bosco” di Giovanni Segantini, 1890

