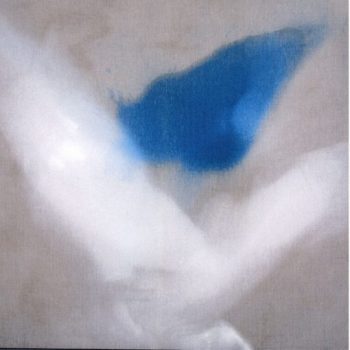Alla Galleria Nazionale di Roma
Per Vasco Bendini
Piccolo ma significativo omaggio a Vasco Bendini, un maestro isolato e schivo del nostro Novecento. Dalla scuola di Giorgio Morandi alla pittura dell'infinto passando per l'Arte Povera. Storia di un artista atipico che non strizzava l'occhio al mercato
Le retrospettive alla memoria mi riportano su quasi sempre un sapore amaro di tristezza. Lo stesso che mi assale visitando il siparietto omaggio che, per i cento anni della nascita, la Galleria nazionale di Valle Giulia riserva per una ventina di giorni a Vasco Bendini (1922-2015), artista bolognese cresciuto alla scuola di Morandi per poi approdare all’informale, transitare per una breve stagione senza mai aderirvi alle esperienze performative dell’arte povera, e poi tornare di nuovo ad inseguire sulla tela l’invisibile con tutti gli strumenti e i materiali che la pittura gli offriva.
E non è solo il rimpianto per la scomparsa di una persona che ho incontrato quasi novantenne, misurando l’ironia, la straordinaria vitalità con cui si portava addosso il peso degli anni, e continuando da allora a gustare a distanza lo stupore e il piacere che mi suscitavano la costruzione, il rigore e la freschezza delle sue opere. Ad impigliarmi nella malinconia è la scommessa che scorgo dietro questa rievocazione, accolta con dichiarato attestato di stima dalla direttrice del museo Cristiana Collu, ma poi relegata in una saletta destinata alle mostre in transito a breve tenitura, isolata dalle sale d’esposizione della galleria riallestite sulla base delle sue preferenze come una vetrina-compendio dell’arte che meglio ha interpretato il tempo deragliato della contemporaneità. Una distaccata attenzione che è già, temo, il segnale delle difficoltà che incontrerà il tentativo di rilanciare la storia interrotta di questo autore, a cavallo tra secondo Novecento e inizio nuovo Millennio, tra le pagine dedicate ai primattori.
Difficoltà accentuate da una marcata lacuna della sua biografia: tre Biennali a Venezia, due Quadriennali, un corposo curriculum di mostre in Italia e presenza in collezioni private e musei di casa, ma un’assenza quasi totale di apparizioni nelle grandi capitali straniere, che dettano mode e tendenze. E la circolazione all’interno del sistema.

Probabilmente il torto maggiore di Vasco Bendini è di essere sempre stato, nonostante l’affabilità dei suoi modi, un artista isolato. Come a molti purtroppo succede. Troppo preso dalla passione del suo mestiere per preoccuparsi del farne mercato. E dunque difficilmente inquadrabile, nelle file di uno dei movimenti d’avanguardia su cui la critica costruisce abitualmente la sua visione dell’arte contemporanea.
È vero ci sono stati negli anni ’60 i suoi esperimenti, le sue invasioni nel campo dell’arte povera. Qualche anno fa, al Macro, Gabriele Simongini ne mise in mostra una dozzina di esempi. Qui, il curatore Bruno Corà ne espone a riprova soltanto uno. Un’istallazione che ruba forma e ombre precarie ad un paio di sedie incastonandole all’interno di una cornice da cui pendono lembi slabbrati di una tela strappata. Un quadro insomma derubato della sua matrice originaria. Perché, finita questa breve parentesi di prova e di esperimenti, Bendini ha poi scelto di ritornare alla pittura, di riprendere a forzare con la sua voglia di dire i vantaggi e i limiti della gabbia a due dimensioni in cui è apparentemente imprigionata.
Trascinandosi appresso una traccia dei suoi sconfinamenti con la scelta e l’uso di materiali presi dalla vita, rubati al sex appeal dell’inorganico: stucchi, ferri, cartoni, ritagli, scorie, polveri da aggiungere come una pertinenza all’uso dei colori stesi in tutte le modalità con cui possono impossessarsi di una superficie. Ora addensandosi a grumi e solcandone come rughe la pelle, ora accendendosi come segnali di un altrove aldilà su stesure più uniformi, nero, bianco, a volte rosso, ora imbizzarrendosi in segni che scalciano disagi, rabbie, speranze, ora svaporando come nebbie granulose, particelle d’infinito da ricomporre.
Già, l’infinito. È la sfida raccolta in modo davvero esemplare nella seconda e ultima sala. Affidata ad una lunga schermata di lavori degli ultimi anni. Può apparire una deriva mistica, ma sarebbe un torto allo spirito laico che sempre lo ha animato. Alla curiosità con cui ha sempre cercato di adattare al suo sguardo, lo sguardo delle discipline scientifiche che inseguono oltre la soglia del visibile le calamite e le vibrazioni delle energie che innervano la materia, si rispecchiano nella vastità del cosmo e nei minimi scarti di relazioni da cui scaturisce la vita.

Un alternarsi affollato di luce e di ombre. Davvero spaesante lo spettacolo di questa stanza. Sulla parete sinistra l’occhio galleggia in una coltre di nubi bianche, solcate da improvvisi sprazzi di segni, che si accavallano in quasi impalpabili sfumature per degradare in reticoli di vibrazioni. Sulla parete destra la cortina di bianco è ancora più densa, ma lascia trasparire all’esterno le traccia vaga di corpi in dissolvenza. In un quadro affiora addirittura un volto femminile e il sorriso ammiccante di un paio di labbra intinte di rossetto.
Sogni, fantasie, che da quegli indizi di figurazione risalgono fino a perdersi nell’indistinto. La vita che rivendica la sua unicità, ma allo stesso tempo sfuma verso gli orizzonti del cosmo. Raro che un artista consapevole di esser giunto alla fine del suo percorso confessi con tanta lucidità il suo oscillare tra il dentro e i fuori, tra il ricordo e l’attesa. Senza mai scivolare in un intimismo di autodifesa e maniera. Calato in un suo tempo interiore che si specchia, però, nel tempo della Storia, del mondo che lo circonda e lo incalza. Esemplare un breve testo che introduceva una delle sue ultime mostre, ripercorrendo gli eventi che avevano raggiunto e ispirato la sua pittura. La paura della bomba atomica, la guerra fredda, il Vietnam, le invasioni dei carri armati russi ad interrompere le eresie libertarie di Ungheria e Cecoslovacchia, ad aprire dubbi e lacerazioni nella sua fede di comunista: un percorso tradotto in una serie di opere, di cui questa mostra ripropone qualche campione di forte impatto.
Temo non basterà a strappare il suo nome e il suo messaggio di artista dalla palude della disattenzione e dell’oblio. Ma spero serva a spingere almeno qualche visitatore a interrogarsi sull’imperdonabile spreco che si consuma nel vortice onnivoro del sistema dell’arte.