Consigli per gli acquisti
Mostri e visionari
Matteo Collura racconta le visioni della Sicilia letteraria, Gian Luigi Beccaria analizza la lingua di Primo Levi e Antonio Manzini ricostruisce un intricato caso di cronaca di provincia in riva all'Adriatico
Sicilia. Si sa: definire una porzione di mondo è cosa difficile. Lo è ancora di più per un’isola triangolare chiamata un tempo Trinacria. Lo scrittore Gesualdo Bufalino, autore di Diceria dell’untore, che considerava il suo paese (Comiso, nel Ragusano), una sorta di arresti domiciliari, volendo capire la natura intrinseca e il carattere dei suoi concittadini, scrisse: «Gli isolani sono spinti a farsi isole dentro l’isola e a chiudere dall’interno la porta della propria solitudine, che vorrei con vocabolo inesistente definire “isolitudine”». E spiegava quel rapporto di complicità, quindi libero: «All’essere soli corrisponde l’eccessiva ospitalità, così celebre nei siciliani, oppure, all’opposto, l’ombroso, claustrofobico rifiuto di ogni contatto e colloquio ( e sappiamo quanto un siciliano sappia essere, se davvero lo vuole, sordomuto). In straordinaria sintesi concludeva: «A un cuore ambiguo un luogo ambiguo».

È una delle tante citazioni fatte da Matteo Collura, nato ad Agrigento e poi trasferitosi a Milano, il più autorevole biografo di Leonardo Sciascia (con Il maestro di Regalpetra), del quale fu anche amico. Ora, con l’editore Salani pubblica Baci a occhi aperti (La Sicilia nei racconti di una vita, 462 pg., 16 euro). È una miniera storica, emozionale, geografica e letteraria. Un libro fondamentale per chi volesse evitare i tanti, troppi, luoghi comuni e avvolgersi di una storia ricchissima, dove s’intersecano abitudini, personaggi, città e paesi. Come ogni isola – pure quindi la Sardegna, l’Elba, la Corsica, e anche Sant’Elena tanto per scivolare nel solco napoleonico – la Sicilia è stata per molto tempo isola-isolamento, luogo dove mandare dissidenti e prigionieri. È tutto cambiato in questi ultimi cinquant’ani. Rimane in piedi la suggestione di uno “scoglio” in mezzo al mare (l’isola di Montecristo, di Dumas padre è sinonimo quasi di invenzione e di mistero). C’è da dire che lo stretto di Messina, nel suo punto più angusto, separa il continente-nazione per soli quattro chilometri. Scrive Collura: «Essere isolani non abbastanza isolati… e anche questo può provocare insicurezze, equivoci, drammi psichici collettivi». Se il sardo sbarca a Livorno, si riferisce a un movimento nella geografia mediterranea. Rifletteva Giuseppe Tomasi di Lampedusa: «Non nego che alcuni Siciliani trasportati fuori dall’isola possano riuscire a smagarsi: bisogna però farli partire molto, molto giovani; a vent’anni è già tardi: la crosta è fatta». Causava meraviglia ma anche paura per i siciliani guardare il mare. Vuole una leggenda, scrive Collura, che la Sicilia sia sorretta da tre colonne, una delle quali sempre più prossima al crollo. E se la catastrofe non avviene è perché un essere per metà uomo e per metà pesce, chiamato Colapesce, ci può salvare. Molti furono coloro che volevano “rubare” l’isola. Si racconta di un marchingegno: una volta sbarcò a Lampedusa un eremita. A seconda che le navi che avvista fossero arabe o cristiane, lui cambiava tunica. Ne aveva due: la prima con i simboli della cristianità, la seconda con i ricami moreschi.
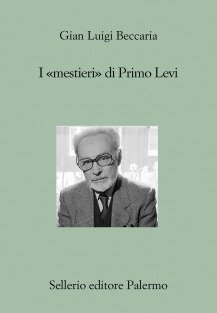
Le radici. Si è laureato in chimica, è stato in un campo di concentramento nazista e quando è tornato alla sua natale Torino, si è diviso tra scrittura e lavoro in un laboratorio chimico, scrivendo libri che nulla avevano a che fare con la Shoa. La sua esperienza di internato era tutto in opere come Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati, il viaggio. Sua opera altamente meritoria è l’aver incontrato classi di studenti cui trasmettere gli effetti dell’orrore vissuto (per sei milioni di ebrei, omosessuali e dissidenti politici) della barbarie tedesca. La sua vera e intima passione era però la linguistica. Lo mette a fuoco Gian Luigi Beccaria con I “mestieri” di Primo Levi (Sellerio, 110 pg., 12 euro). Grande gioia da bambino quando gli regalarono il primo dizionario. Col tempo se ne aggiunsero molti altri, soprattutto quelli etimologici. Cercava sia l’origine delle parole, sia le connessioni e, nel caso dell’ebraico, le varie contaminazioni a causa degli spostamenti di persone. Divertendosi affermava di occuparmi di «cose che non capisco». Le scoperte erano argute, rare e interessanti, con un vago rimando alla poesia di Gozzano (Levi scrisse anche poesie). Nello stesso tempo voleva, in un certo senso nobilitare il piemontese, dimostrando che certe parole avevano fatto un balzo nella lingua italiana senza intermediazioni. Il yiddish parlato negli Usa lo affascinava. Qualcuno, spiegava, usa ancora l’espressione “na vesta a kinìm” per dire vestito a puntini. Kinìm nella sua accezione originaria significa pidocchio, la terza delle dieci piaghe d’Egitto. Dalla radice Shafòkn, che vale a spandere secondo il Salmo 79: «Spandi i tuoi regni che non invocano il Tuo Nome, deriva da vomito neonatale». Da Havertà (arbitraria forma femminile di compagno) proviene Havèr, letteralmente compagno, e si usa come domestica, contenente l’idea accessoria della donna di bassa estrazione e di credenze e costumi costretti ad albergare sotto il nostro tetto. Anche nei romanzi che nulla avevano a che fare con i lager nazisti, Levi fa parlare il protagonista (per esempio Faussone) con un linguaggio strettamente legato alla sua professione di operaio.

Il lutto. Il nuovo libro di Antonio Manzini, l’“inventore” di un personaggio bizzarro e trasgressivo come il vice-questore Rocco Schiavone, si ispira a un fatto vero. Il fondale non è più la Valle d’Aosta, bensì la costa adriatica che va da Pescara a Roseto. I protagonisti sono due coniugi sessantenni, imbozzolati in un lutto cupo. Corrado, il loro figlio, ventitreenne, studente di Giurisprudenza è stato accoltellato da un balordo, Paolo Dainese. Il ragazzo quel giorno dava il cambio al padre, proprietario di una tabaccheria. L’aggressore sconta solo sei anni di prigione. Riconquistata la libertà, Paolo Dainese diventa uno spettro atroce. I genitori della vittima reagiscono in modo diverso, e a questo punto l’autore cerca di scavare nella psicologia dei due. Lo fa con Gli ultimi giorni di quiete, 231 pg., 14 euro, Sellerio editore. Manzini procede lentamente senza trascurare alcun particolare (un po’ alla Truman Capote), col rischio di essere qua e là dispersivo, almeno su alcuni fatti laterali rispetto alla vicenda emotiva. Ambedue i genitori si chiedono dove viva l’uomo (“il mostro”) che la giustizia dei tribunali ha effettivamente trattato con magnanimità. E tra loro si apre una distanza emotiva, almeno sul chiedersi che fare. Il padre Pasquale, titolare di una tabaccheria si procura al mercato nero una pistola e con quella si esercita in un suo vecchio casolare. Si rende però conto che una cosa è sparare a un divano o a un mobile, un’altra è colpire al volto o al petto l’assassino. La moglie Nora prende un’altra strada, con una pazienza e una determinazione che pochi avrebbero. Con vari stratagemmi si traferisce a Roseto, dove ha scoperto l’abitazione del Dainese e il negozio di parrucchiera di sua moglie. Sta interminabili ore in agguato, facendosi vedere dal suo obiettivo al quale, con voce trattenuta, diremmo dignitosa, riesce a dirgli “assassino”. I suoi occhi sono cupi, come vuoti. La stessa parola la scriverà sull’auto dell’“avversario”. Da questo momento l’equilibrio si spezza. I datori di lavoro del Dainese non garbano di certo la sua presenza davanti ai cancelli dell’officina dove questi lavora. Nora poi tappezza una vasta superficie di muri con volantini. La scritta è sempre la medesima. All’inizio viene sbrigativamente ipotizzata come pazza. Il Dainese entra nel vortice dell’accusa sociale e dell’isolamento. Un giorno, dopo tante domande a vuoto, la trova davanti a sé mentre con tutta tranquillità (solo palese) fa la prima colazione nell’albergo dove da giorni risiede. E il mostro ridiventa mostro. Il finale – che ovviamente non riveliamo – è raccapricciante.

