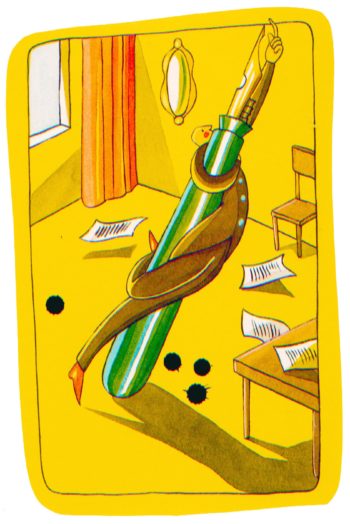Lo scaffale degli editori
Quel frate cercone
Così si dipingeva Romolo Valli, a cui dedica una bella monografia Daniela Montemagno, sempre in giro per trovare sovvenzioni pubbliche ai suoi progetti. Mentre su Monicelli è incentrato l’ultimo numero del quadrimestrale “Bianco e nero”. E Alberto Mattioli, “Pazzo per l’opera”, insegue la sua passione in 1.800 messinscene…
Privati del cinema e del teatro dal rigurgito prevedibile dell’epidemia, si situa tra nostalgia e risarcimento l’uscita di due titoli su altrettanti giganti della scena e dello schermo. Sono entrambi pubblicati dalle Edizioni Sabinae, che dedica soprattutto allo spettacolo i suoi raffinati libri e periodici. Ecco allora a tutta copertina, sul primo, la fotografia di un protagonista del palcoscenico italiano del secondo Novecento, Romolo Valli. Un attore che ha segnato messinscene delle quali tutta la cultura italiana parlava, quando ancora il teatro era centrale nelle predilezioni dello spettatore: un’epoca d’oro, attraversata da giganti della recitazione. Ebbene, Romolo Valli li ha intercettati tutti, con loro è stato protagonista: ed erano Paolo Stoppa e Rina Morelli, Buazzelli, Tino Carraro, Lilla Brignone, Anna Maria Guarnieri, per non dire di Rossella Falk, la trascinatrice della Compagnia dei Giovani.
Non un mattatore, Valli, piuttosto un preciso realizzatore di personaggi drammaturgici e letterari, con exploit del peso di Leone Gala nei pirandelliano Il gioco delle parti, di Argante nel Malato immaginario di Molière, di Otto Frank ne Il diario di Anna Frank. Che adesso, a quarant’anni dalla sua scomparsa, Daniela Montemagno – tra l’altro conservatrice della Biblioteca del Burcardo – ci restituisce in una biografia ricchissima (anche, nella parte finale, di testimonianze, lettere, riflessioni dell’attore, nonché dell’intero catalogo delle messinscene, dei film, delle presenze televisive e radiofoniche). Si intitola tout court Romolo Valli (411 pagine, 20 euro), reca come si accennava in copertina il magnetico primo piano su sfondo nero di Valli nei panni di Henry Jarvis ne Il carteggio Aspern da Henry James, anno 1961. Con la sua vita sciorina capitoli della nostra storia: in locandine memorabili, in fotogrammi di culto. Perché Valli – nato nel 1925 a Reggio Emilia (una gioventù durante la quale incontra Luzi e Morandi, Ligabue e Sereni) – approdato al teatro con il Carrozzone itinerante di Fantasio Piccoli, poi al Piccolo di Milano di Strehler dove per la prima volta, agli inizi dei Cinquanta, recita nei Sei personaggi di Pirandello – è stato anche febbrile organizzatore di teatro: in qualità di direttore artistico del Festival di Spoleto e dell’Eliseo di Roma.
Attento ai cambiamenti che necessitavano alla scena, prima aderendo con i Giovani all’idea di un teatro libero dalla “dittatura” degli impresari e dei registi (anche se Giorgio De Lullo fu, da regista e da compagno, il suo partner per tutta la vita), poi sensibile alla rivoluzione del Sessantotto, quando si recitava nelle cantine. Infine, appunto, all’Eliseo, capace di intercettare praticamente la voglia di nuovo: ecco l’inizio degli spettacoli alle 20,30, i prezzi ridotti per i giovani, le conversazioni del martedì. Negli ultimi anni, già tirando le somme, ebbe a dire che avrebbe voluto essere attore come Salvo Randone, regista come Strehler, impresario come Paolo Grassi. Anzi «attore-regista-impresario tutt’assieme, perché la definizione che in fondo più gli stava a cuore era quella di “animatore teatrale”». E anche “frate cercone” come diceva ironico di sé, sempre in giro per trovare sovvenzioni pubbliche ai suoi progetti.
Prima di morire a cinquantacinque anni – andando a sbattere contro un muro a bordo della sua Rover mentre alle due di notte filava sulla via Appia per tornare a casa – fu anche attore di cinema: per Visconti ne Il Gattopardo (l’ambiguo don Pirrone) e in Morte a Venezia (l’untuoso direttore d’albergo), per Bertolucci in Novecento, per Monicelli ne La grande guerra e ne Un borghese piccolo piccolo.
E proprio a Monicelli è dedicato il numero da poco uscito del quadrimestrale “Bianco e nero”, che le Edizioni Sabinae pubblicano con il Centro Sperimentale di Cinematografia (ciascun singolo volume costa 18 euro, l’abbonamento annuale 32 euro). Anche qui una ricorrenza, i dieci anni dalla scomparsa del regista. Una morte sensazionale pure questa: Monicelli, novantacinquenne, era ricoverato all’ospedale San Giovanni di Roma e in preda alla depressione per l’età e la malattia, un cancro, si suicidò gettandosi da una finestra. Era il 29 novembre del 2010. «Ho vissuto abbastanza, e poi la morte non la temo», diceva negli ultimi tempi, come ricorda nell’editoriale Felice Laudadio. E come ribadisce lo stesso regista – un toscano anticonformista, rude, ironico, non sarcastico, che inanellò 65 pellicole – nell’intervista (del 2009) che apre “Bianco e nero”: «Me la sono cavata, non nutro nostalgia per il passato anche se provo orgoglio per questo paese e per la sua gente, ripensando a come erano i tempi della mia gioventù», allorché «una leva di italiani, la mia, avendo subito nella propria carne una dittatura stupida e una guerra ridicola, seppe poi comportarsi in maniera fattiva e solidale». Mentre ora «la nostra povera penisola va alla deriva su un Mediterraneo che rappresenta ormai una immensa tomba per chi viene dal terzo mondo».
Poi gli articoli-saggi: per Franco Cardini L’Armata Bracalone si accosta figurativamente all’albero degli impiccati e ha come “padri” Villon, Dürer, Buñuel; per Giancarlo De Cataldo il giustiziere Sordi nell’Italia anni Settanta è “un borghese di paglia”; per Giulio Ferroni la “supercazzola” l’ha inventata Boccaccio nella scia della beffa toscana. Giancarlo Giannini ricorda quando gli disse, seduti al bar Canova, poco prima che morisse: «Sei meglio di Billy Wilder. Perché hai fatto tutti i generi cinematografici, anche quelli che Wilder non ha fatto». E poi: «La sua simpatia risiedeva nel suo essere burbero. Smontava e smitizzava tutto. Era la sua filosofia di vita. Non l’ho mai visto arrabbiarsi sul set. Non ne valeva la pena. Per lui il cinema era un gioco». Di Monicelli parlano, tra gli altri, Ornella Muti (alla quale giovanissima e incinta della prima figlia, disse, sul set di Romanzo popolare: «Torna nel mondo, non vivere a Disneyland»), Michele Placido e Milena Vukotic, che chiamò per Amici mieie Amici miei II. Lei pure dipinge Monicelli come «burbero e sornione» mentre girava, concentrato sulla scena, rapido.
Le foto della rivista, tutte in bianco e nero, restituiscono gli innumerevoli titoli di Monicelli, anche i meno memorabili, come Facciamo paradiso con Margherita Buy. Poi ritroviamo l’Aldo Fabrizi di Vita da cani, il Sordi di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, la Monica Vitti de La ragazza con la pistola. Davvero la Rai, in questo ritorno del lockdown, dovrebbe consolarci con una retrospettiva dedicata a Monicelli.
Ci mancherà anche l’opera, a causa del coronavirus, che ha cancellato perfino la prima della Scala. Allora, andiamo nei teatri lirici di tutto il mondo con il libro di un melomane incallito, Alberto Mattioli, giornalista per La Stampa. Il suo Pazzo per l’opera – Istruzioni per l’abuso del melodramma (Garzanti, 216 pagine, 16 euro) rincorre l’ossessione per la geniale invenzione italiana, inseguita dall’autore nei tre continenti, per un totale di 1.800 messinscene. L’opera, per l’autore, mantiene intatto il suo «misterioso potere emozionale» e la racconta non solo a chi la frequenta ma a chi vorrebbe farlo o ne è solo incuriosito: dai teatri italiani che hanno reso nazionalpopolare il melodramma, quando Rossini, Verdi e Puccini erano la colonna sonora della vita di molti, alla lirica di oggi, fenomeno globale multimediale: uno spettacolo capace con i capolavori del passato di leggere il nostro presente e di continuare a farci piangere, ridere, riflettere. Le ragioni dell’amore irrazionale e sfrenato di Mattioli, al punto da fargli sostenere che «finché c’è l’opera, c’è speranza».