A proposito di “Al cinema con lo psicoanalista”
Il cinema è sogno
Lo psicoanalista Vittorio Lingiardi si insinua nel rapporto tra l'inconscio e il cinema, terreno di coltura di ombre e sogni. Da Buñuel a Fellini, da Bergman a Pasolini: un catalogo di immagini stese sul lettino
Il cinema: una sequela di persone, ma anche animali, grida, sussurri, silenzi, guerre, coppie di amanti, avventure, fantascienza, ghiaccio e sabbia, prigionìe e così via. Il tutto su un telone bianco che si chiama schermo (o televisione, ossia piccolo schermo). Tutto vero, ma la definizione è limitante. Soprattutto per Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista e docente alla Sapienza di Roma. Nel suo libro, Al cinema con lo psicoanalista (Cortina editore, 200 pg., 15 euro) espone la sua teoria: «Oliver Sacks affermava che dobbiamo avere noi stessi; possedere, se necessario ripossedere noi stessi, la storia del nostro vissuto. L’uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo. Il cinema è capace di darci questo racconto. Sì, anche se fosse la storia di un pellerossa o il degrado doloroso di Nanà (gran bel romanzo di Emile Zola, ndr)».
Lingiardi parafrasa Michel de Montaigne e scrive che «un film è metà di chi lo gira e metà di chi lo guarda», senza dimenticare il radicalismo culturale di Jean-Luc Godard: «Ciò che è sullo schermo è già morto: è lo sguardo dello spettatore a insufflarli la vita». L’autore, già inventore della rubrica Psyco (sull’Espresso), è convinto che il cinema racconta storie che sono contemporaneamente di tutti e di ciascuno: «Grazie alle storie costruiamo la nostra identità».
Entra in gioco la psicoanalisi: «Luce e buio: ecco il cinema. Ma anche la psiche, fatta di chiarori e oscurità, di forza e paura. Perché cinema e psiche, insieme? Perché sono fatti della stessa sostanza, storie e immagini. Il cinema è un grande esperimento sul sogno e la memoria. Di continuo li richiama e li confonde, trasformandoli in storie che non sono più quelle che seguiamo sullo schermo. Perché sono diventate nostre. È uno scambio: i personaggi ci raccontano le loro storie così noi possiamo prestar loro le nostre emozioni… dopo aver visto un film mi sento più analizzato che analista; la mia poltrona, per una volta, non è dietro per interpretare ma davanti per partecipare».
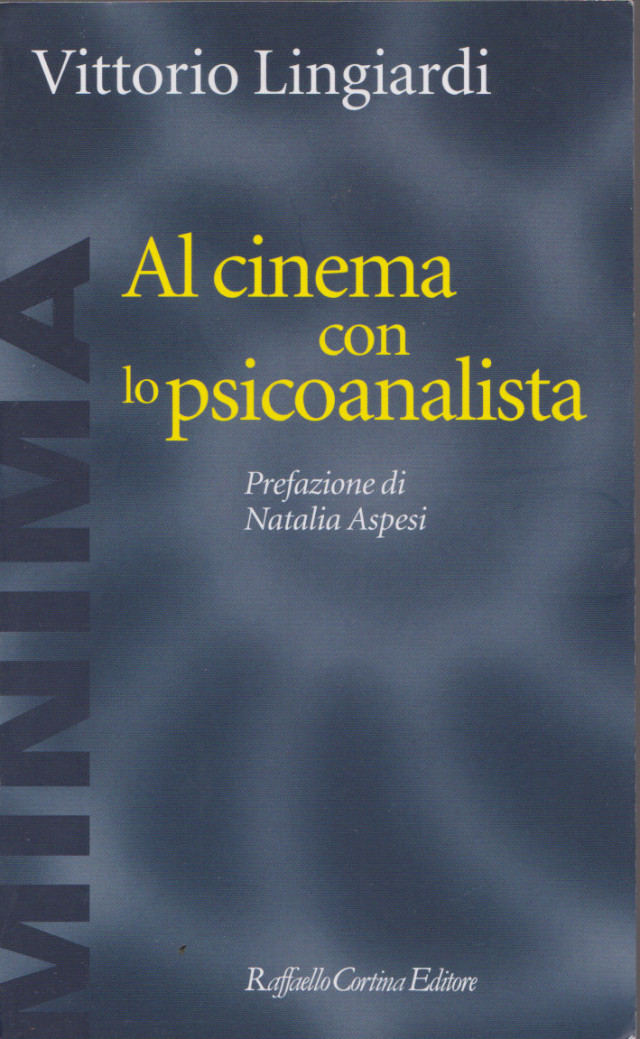
Nell’acuta e brillante prefazione a questo saggio, Natalia Aspesi si dice convinta che «siano i film a scegliere di distendersi sul lettino dello psicoanalista e non il contrario». E, dopo aver confessato di essere un’indomabile cinefila, aggiunge che tra vicende narrate sul telone bianco e psiche c’è «un’affettuosa comunicazione», anche quando le sceneggiature sono brutte, perché «è ovvio che un film può sempre voler dire altro da quel che mostra, senza appellarsi all’inconscio». La giornalista ricorda puntualmente che in Iran e in altri paesi totalitari finiscono in galera registi giudicati irrispettosi del regime, mentre in tempi meno occhiuti si andava a vedere La contessa di Parma e la censura non si rendeva conto di quanto il regista Blasetti, raccontando di sarti e modelle, irrideva l’obbligo fascista di usare il Voi al posto del Lei».
Il cinema reclama riflessione, sfiora il cuore o in certi casi ne causa forti aritmie. E ti resta dentro per ore, giorni, decenni. Non è mera coincidenza, secondo Vittorio Lingiardi, che una delle prime pellicole presentate a Parigi dai fratelli Lumière, intitolata L’arroseur arrosè (49 secondi) ordinò il buio in sala nel 1895, lo stesso anno in cui Freud pubblicava Progetto di una psicologia.
Il saggio pubblicato dall’editore Cortina, sostiene sempre la Aspesi, «racconta tutto delle nostre vite come le vede lo schermo visto da Lingiardi. Ci svela noi stessi svelando storie e personaggi, magari lontanissimi dal nostro vivere eppure specchio di inquietudini che ci appartengono». Un film ha diverse vite, secondo chi le guarda e nei diversi momenti in cui lo si vede, e persino con chi.
Lingiardi, prima di riportare le sue critiche ai film – racchiuse appunto nella rubrica Psyco – ricorda le varie definizioni date del cinema da parte di grandi intellettuali. Secondo Arthur Schnitzler «l’inconscio è un territorio molto esteso in cui ci sono più interruzioni e intrichi di strade di quanto gli psicoanalisti sospettino». Ingmar Bergman, «quando un film non è un documento è un sogno». Per questa ragione, asserisce Lingiardi, Tarkovskij «è il più grande di tutti». Bergman, quando gira Fanny e Alexander (prima come serie televisiva di cinque ore poi ridotte a tre con un film) fissa gli occhi che guardano, guidando i nostri a scoprire il cinema-vita, sono quelli di due bambini, fratello e sorella, in una famiglia benestante, formata da teatranti svedesi all’inizio del Novecento. «Il piccolo Alexander-Ingmar gioca con la lanterna magica e dice bugie per sopportare la realtà. La nonna dà l’esempio leggendo Il sogno di August Strindberg: tutto è possibile e verosimile. Su una base insignificante di realtà l’immaginazione tesse nuovi disegni». Il sogno dell’infanzia, quando non è violato. «È il sogno del cinema» scrive Lingiardi.

Pier Paolo Pasolini considerava Uccellacci e uccellini «il più povero e il più bello dei miei film». In questa pellicola, proiettata parzialmente in un convegno di psicoanalisi, Frate Francesco spiega a Fra Ciccillo (Totò) la loro missione di evangelizzare falchi e passeri. Ciccillo impara a comunicare con i falchi, semplicemente fischiando, ossia usando il loro linguaggio. Ma la stessa operazione non funziona con i passeri. Scrive Lingiardi: «È sul punto di abbandonare quando, osservando Fra Ninetto (l’attore Davoli, ndr) che si distrae giocando a cianchetta (“Non so’ bono manco a parlà co la gente, mo parlo co’ gli uccelli”) capisce che i passeri non comunicano col canto, ma saltellando. Quale immagine migliore per rappresentare l’invenzione di un linguaggio e al tempo stesso la sintonizzazione con il mondo dell’altro». L’autore confessa di aver visto e rivisto questo “povero” film come omaggio alla «disperata vitalità del dialogo analitico, mentre saliva la malinconia per la progressiva scomparsa di quello politico».
Per Federico Fellini il cinema «somiglia a una memoria che viene prima della memoria. È, insomma, un immaginario affettivo sognato. Stanley Kubrick diceva che 2001: Odissea nello spazio «Aggira la comprensione per penetrare bell’inconscio». Bernardo Bertolucci s’accorgeva che qualcosa affiorava alla superficie della (sua) coscienza e questo lo capiva solo alla fine delle riprese. E aggiungeva che «l’incontro con la psicoanalisi aveva trasformato i suoi film da monologhi in dialoghi».
Se per Luis Buñuel un film è «un’imitazione involontaria del sogno», Carl Gustav Jung vedeva i sogni come lo sforzo di «esprimere qualcosa che sa ma non capisce». Il sogno non è sempre un’evasione, diceva Fellini. Certamente il regista romagnolo ci ha consegnato un universo onirico. Ma il suo Satyricon, scrive Lingiardi, «non è la ricostruzione di un’epoca, ma una grande galassia onirica, affondata nel buio, fra lo sfavillio di schegge fluttuanti, galleggianti fino a noi. Frammenti di Appia antica che affiorano da un sogno in gran parte rimosso». L’intenzione di Fellini è quella di ricostruire il sogno nella sua «trasparenza enigmatica», nella sua «chiarezza indecifrabile».
Lingiardi ci racconta di aver rivisto in periodo di pandemia Il settimo sigillo di Ingmar Bergman «con la tentazione banale – come sono spesso le tentazioni – di avvolgere il cine-filo delle pestilenze». Il film, il cui titolo è preso dall’Apocalisse, è un’allegoria sulla certezza della morte e la ricerca di Dio mentre la pestilenza svedese del 1350 miete il suo raccolto. Il personaggio Antonius, diversamente dallo scudiero Jons, che è materialista, è tormentato dal dubbio della fede. «Il suo cuore è vuoto, la mente preda di a incubi di lucidità. Diceva il resista: «Perché Dio si nasconde? Forse gli uomini – si domandava freudianamente – intagliano nella loro paura un’immagine alla quale poi danno il nome di Dio?».

