A proposito di "Isolitudini"
Scrivere è viaggiare
Massimo Onofri continua a sperimentare linguaggi (e temi) critici lontano da ogni forma di accademismo e vagando un terreno nel quale la letteratura diventa un paesaggio dove il "fuori" dei panorami corrisponde alla landa desolata del “dentro” del proprio Io
Stando ai libri che Massimo Onofri è venuto scrivendo da qualche anno a questa parte, mi pare evidente l’emergere di una precisa direzione intrapresa nelle scritture ibride del critico viterbese: da una parte il viaggiare, con i due Passaggi (in Sardegna e in Sicilia, rispettivamente del 2015 e del 2016), assunto come condizione e metafora fondamentale; dall’altra, quella particolare forma di viaggio propria a colui che Onofri sembra assimilare al viaggiatore per antonomasia: lo stanziale che, come accadeva già in Benedetti toscani. Pensieri in fumo (2017), vede coincidere il viaggio con la riflessione, la fantasticheria. E a cui fa seguito, felice completamento di quell’ipotesi del sostar viaggiando o del viaggiar sostando, questo ponderoso “Atlante letterario delle isole e dei mari” che è Isolitudini (La nave di Teseo, € 23,00, pp. 492, illustrazioni di Jessica Lagatta). Libri contigui e per nulla estemporanei, in cui il personaggio-uomo è sempre lo stesso: l’intellettuale ironicamente narciso, innamorato, ossessionato dai suoi incubi (si pensi all’eroicomiche vicende dell’immaginaria Petra o al fantasioso bestiario di tipi umani) e dai suoi slanci amorosi; non meno impegnato ad esibire le tracce manifeste di quello che egli stesso, da tempo, ha voluto rubricare come “stilnovismo patologico” (sentimentale e bovaristico). E le cui argomentazioni sono accomunate da un certo malinconioso sigillo, a fungere da basso continuo.
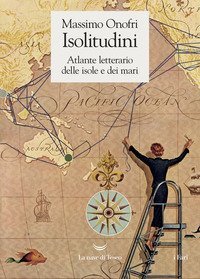
Nemmeno in un libro certo dal differente taglio come quest’ultimo disdegna talune incursioni autobiografiche, come quando (parlando dell’amato Stevenson) consegna a una densa e fresca pagina il racconto della sua infanzia tra i ragazzi di via della Pila a Viterbo. Ché Onofri sembra considerare clamorosamente smentita la proustiana distinzione tra ‘io che vive’ e ‘io che scrive’, per quel vertiginoso inframmischiarsi di piani, che lo induce, non di rado, a strizzare l’occhio al Sainte-Beuve. Il suo credo appare perciò ricompreso entro quell’alveo i cui argini sono, da un lato, la solitudine, dall’altra il balsamo d’una caustica immaginazione. Di qui la denuncia della difficoltà, per chi viva di letteratura, come aveva già scritto in una nota di Benedetti toscani, di “tenersi in equilibrio sulla zattera della realtà”. Tema del viaggio che campeggia, centrale, sin dal titolo, anche nella sua più recente silloge di saggi tradizionali sul Novecento italiano, Fughe e rincorse (2018). Disposizione al viaggio che Onofri, indagandola in Mario Soldati, uno degli autori senza dubbio più cari della sua costellazione, chiarisce a se stesso come, nel più articolato rapporto tra scrittura e vita, di quel movimento, di quell’arte della fuga, essa rappresenti l’epitome esistenziale, il correlativo oggettivo.
Ecco: qui, in Isolitudini, è sfruttato al meglio, in maniera ancor più se possibile programmatica, in tema d’invenzione stilistica, il rapporto profondo tra scrivere e viaggiare, come lo stesso scrittore suggerisce nelle pagine dell’Atlante dedicate al Viaggio sentimentale di Laurence Sterne. Ma di quel viaggiare da intendere come stanziale o peregrina meditazione, come gli suggeriscono il de Maistre del Viaggio intorno alla propria camera e il Rousseau delle Fantasticherie del passeggiatore solitario. E se in Benedetti toscani la sua immaginazione, nel compiersi puntuale del rituale notturno della “sigarata” in Piazza Vittorio, ci portava a scorgere il mare della collinare Viterbo (“il mare c’è, per chi sa vederlo”); in questo andar per isole del solito “etrusco estinto nato per restare a terra”, apparecchiando sul tavolo tutti gli atlanti possibili, al solo lume d’una solitaria e rapinosa immaginazione, il dito ostinatamente puntato sopra le carte, non ha fatto altro che inseguire quel breve illusorio sogno dell’infinito che tanta poesia del Novecento ha infine ridimensionato e smentito (non è un caso che a suggellare il libro chiami in causa i versi di un poeta che come pochi altri fu “in confidenza col nulla” come Bartolo Cattafi). L’idea di scrivere un libro simile può darsi sia venuta ad Onofri dal compulsare quell’Atlante delle isole remote (2013) di Judith Schalansky; ma quel che è certo è che Isolitudini sia da leggere come l’espressione manifesta del bisogno dell’autore di spatriarsi, qui sublimato in un Atlante letterario, a formare un’unica prismatica isola plurale. A dire dell’”isolitudine” come condizione sentimentale ed esistenziale insieme –, come chiarisce nelle belle pagine dedicate a L’isola del tesoro di Stevenson, romanzo che il critico viterbese definisce “programmaticamente superficiale”, a planare sul mito di una mai perduta infanzia dell’uomo. La geografia esistenziale di Massimo Onofri è con piena evidenza imperniata sulla congiunta spirale doppia, per cui il ‘fuori’ del paesaggio corrisponde, quando non addirittura si muta (e in esso soltanto risolvendosi), nella landa desolata del ‘dentro’ del proprio Io.

E per renderci conto di come ciò possa accadere si leggano le pagine densissime dedicate a un libro “bello e terrificante” come Le isole incantate di Melville, in cui l’esotico è “ridotto all’osso dei fantasmi interiori dello scrittore”. Geografia esistenziale che, in definitiva, gravita attorno a due polari coordinate di destino, che Onofri vede con paradigmatica forza inscritte, per esempio, nelle “due Svezie” di scrittori antitetici come Stig Dagerman e Björn Larsson: alfiere, il primo, del farsi ”isola di sé a se stesso”; il secondo, dell’isola come evasione e utopica rincorsa verso una perenne giovinezza. Nell’aspirazione a scrivere, sulle orme dell’amato Walser, un ultimativo libro dell’io degli anni Duemila, Onofri, come scrittore, è senz’altro da ascrivere a questa seconda schiera di autori che rintracciano la loro fede tutta laica e terrestre nell’inseguimento di una solare immagine di imperitura giovinezza. I suoi rimangono “libri performativi”, aperti anche al ‘non-scritto’ oltre la pagina, e attraverso i quali declinare una scrittura che valga come agone esperienziale, nella spola continua tra “prepotente presenza biologica” e il rameggiare di casi singolari, di isole lontane, di plausibili orizzonti, poco importa se reali o immaginari.
Il racconto critico, di ciò sembra abbia voluto dar testimonianza negli ultimi anni Massimo Onofri, può, deve passare per il filtro di un io soltanto in apparenza ipertrofico, che si dilata sempre più fino a diradarsi, diventare frontiera privilegiata di accesso alla realtà. È, il suo “egotismo critico”, il modo più naturale di praticare quello che egli stesso aveva definito in Benedetti toscani come una ”estetica del connettere” (si rammenti l’”Only connect” che Morgan Forster appose al suo Casa Howard), sorta di ossimorica razionalizzazione di quel principio analogico proprio della poesia. Si è detto dell’agire dell’utopia di una inseguita giovinezza di cui, Isolitudine, sembra il frutto finora più compiuto. Epperò non ci s’inganni: se metafisica c’è, in Onofri, come quella del resto ravvisata in Cassola nel saggio che gli dedica in Fughe e rincorse, è quella dell’inequivocabile avvertimento della vita come “perdita secca”, formula che arrota nei suoi discorsi come un mantra; e che tuttavia, più che dalla parte dell’arreso Montale, lo spinge, ancora una volta, sulle orme del più “egoista” degli scrittori italiani: Mario Soldati. Non resta che attendere verso dove – attraverso la pratica di una scrittura ibrida che tutto tiene insieme, mediante i suoi tic linguistici, le sue ossessioni prosodiche –, il critico-scrittore viterbese orienterà i suoi futuri cardiogrammi.
domenico.calcaterra@gmail.com

