A proposito di "Tiatru"
Teatro De Vita
La nuova, bella raccolta poetica di Nino De Vita è quasi una commedia umana fondata sul primato della parola. E nei ritratti giocosi della sua umanità c'è un appello a evitare di utilizzare le parole solo per deformare i fatti
Nell’ultima delle cinque sezioni che compongono il nuovo libro di poesie di Nino De Vita (Tiatru), interamente occupata dal poemetto Bberengariu, il protagonista, nel suo modo logorroico e scompaginato di rivolgersi al prossimo, in questo caso rappresentato dal poeta stesso, dichiara la sua ossessione per le parole: «Pizzuti su’, bbaioti, cummattusi / ‘i palori, ggilusi. / Si rici vannu ritti / abbissati, ncucchiati: stazzunaru, / faccifaria, lappusa, stiraellonga, / sbagnari, rrizzutedda, sparaciaru, / ggesù… / ‘U viri comu sònanu. / ‘Unn’i lìanu renti. / Siddu ‘unn’u fai si mìttinu a farsiari, / fannu trinchititrànchiti. / Sunnu sciacqualatucchi, / ‘u sbiognaparintatu, / zzurbi, malafiuristi, / ô ‘n omu ‘u mpiricùddanu». Che vuol dire che le parole sono altere, villane, complicate, gelose, che «se le dici vanno dette / accoppiate, assonanti». In questo modo infatti non “allegano denti” e se non si fa proprio così esse «cominciano a sbandare, / stonano, stridono. / Sono delle miserabili, / il disonore di una famiglia, / infami, deformano i fatti, / portano un uomo alla sventura».
L’esposizione di Berengario sembra contenere una dichiarazione di poetica e anche, visti i tempi, i nostri, un appello a evitare di utilizzare le parole solo per deformare i fatti: meglio allora che esse si presentino come fossero solo un gioco, come accade nella poesia, così da rendere significativi anche i suoni e il loro modo, spesso misterioso, di accoppiarsi. Ma il modo in cui Bberengariu sciorina le sue confuse verità, lascia intravedere anche altro: che la vita cioè può essere a volte insolente e ignobile, come “caiuna” e “pinesa” sono troppo spesso “i palori” nell’esistenza di ognuno di noi e che le parole possono portare con loro “cosi chi su’ nno trùbbulu”, fatti che sono nell’oblio. È proprio questo il nucleo intorno a cui ruotano le tredici storie di Tiatru, che Nino De Vita, una delle voci più interessanti della poesia italiana di questi anni, affida ancora una volta alla casa editrice Mesogea, da tempo impegnata a curare la pubblicazione di tutte le sue raccolte.
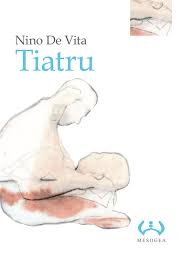 Come in un teatro, i personaggi a cui il poeta di Marsala dà voce nel dialetto parlato dalle sue parti, mettono in scena se stessi, sono reticenti e disponibili, confessano le proprie debolezze e alimentano i nostri dubbi, riesumano fantasmi e avvenimenti provenienti da un passato che solo loro conoscono, e infine ci dicono che quello che la vita sembra comporre in un ordine preciso, è invece disordinato, vago, incomprensibile, e che l’unico vero destino è nell’incompiutezza, nell’impossibilità di condurre a termine un progetto. Avviene dunque che i personaggi di De Vita ci lascino, e lascino i loro interlocutori, frastornati, disorientati, alla ricerca di una tessera utile a ricomporre un destino, di una parola che sappia spiegare la scelta che ha cambiato il corso di un’esistenza.
Come in un teatro, i personaggi a cui il poeta di Marsala dà voce nel dialetto parlato dalle sue parti, mettono in scena se stessi, sono reticenti e disponibili, confessano le proprie debolezze e alimentano i nostri dubbi, riesumano fantasmi e avvenimenti provenienti da un passato che solo loro conoscono, e infine ci dicono che quello che la vita sembra comporre in un ordine preciso, è invece disordinato, vago, incomprensibile, e che l’unico vero destino è nell’incompiutezza, nell’impossibilità di condurre a termine un progetto. Avviene dunque che i personaggi di De Vita ci lascino, e lascino i loro interlocutori, frastornati, disorientati, alla ricerca di una tessera utile a ricomporre un destino, di una parola che sappia spiegare la scelta che ha cambiato il corso di un’esistenza.
I personaggi che dialogano in questi brevi racconti in versi sono parte di un’umanità sofferente, che vive un tempo che non è più il proprio e si muove all’interno di un mondo che forse da tempo non esiste. Donne e uomini tanto più veri proprio nel momento in cui scoprono che non c’è nessuna verità in cui credere, vagamente innamorati della vita, ma solo da quando la vita li ha lasciati malandati e senza fiato.
Sono personaggi bizzarri e tormentati, quelli che animano i versi di Tiatru. Come Solidea, che è tornata dall’Argentina e vorrebbe raccontare al ragazzino Nino le storie di Cutusio (è il luogo dove vive il poeta). Oppure ‘u rumitu, l’eremita, che scrive anche lui poesie, anzi che le poesie le compone nella propria mente e le recita solo in occasione di una festa, «pi rispettu ru Santu». O ancora come Ggiovannineddu u’ foddi, il pazzo, che nella pausa del suo lavoro contadino si rivolge al ragazzino che lo ha spiato, spiegandogli che «stu pani è pisci e stu / cutteddu una trunchisa; / stu vino è focu, e ammeci / sta bbuccetta un furcuni”, cioè che il pane è un pesce, il coltello una tenaglia, il vino è fuoco e invece la forchetta un rastrello, e che insomma “sugnu foddi, un foddi, / unu ch’è scancaratu”, urla Giovannino, mentre il povero Ninuzzu “fuìa spirdutu a pperi / nculu».
E che dire di Turiddu ‘u salinaru, impegnato nel suo faticosissimo lavoro, «che munta ‘i veli / nne mulina, suppia / ri no mari, fa ‘u sali», che consiglia a un ragazzo che chiede di essere assunto a tutti i costi, visto che i primi tre giorni di lavoro saranno di certo i più difficili da affrontare, «pi sti primi tre gghiorna /’un mmèniri», insomma di presentarsi direttamente al quarto giorno.
Nino De Vita rappresenta questo mondo turbato e sofferente con uno sguardo paziente e affettuoso, sposandone in qualche modo la farneticante saggezza, attraverso una lingua, al contrario, estremamente equilibrata, che sembra provenire da una tradizione epica popolare, che si ciba dei suoi suoni e che si alimenta delle improvvise deviazioni di significato. È la lingua della poesia che si sposa con quella dei cantastorie e che diventa capace di raccontarci la nostra umanità, perché, così come predica Bberengariu, «un omu / è fatto ri palori».

