Fiabe in versi a ritmo di Walser
C’era una volta per una selva oscura
Pubblicato per la prima volta a Zurigo nel 1978, a 40 anni di distanza Adelphi ne propone la traduzione italiana: “Komödie” (“Commedia”) è la fiaba in versi di Robert Walser. Oscillando tra la ricerca francescana dell’amore incondizionato e quella freudiana dell’amore materno, Walser plasma le fiabe dei Grimm con il gusto dantesco di una ritmata provocazione lessicale
«Quel tanghero che vuole?» si chiedono le sorelle di Cenerentola scorgendo il principe. Non fosse un interrogativo tipico walseriano, si penserebbe che a pronunciarlo sia stato zio Paperone in una delle sue celebri tirate contro Rockerduck. Ed è incredibile come da uno stilema disneyano si passi ex abrupto al sommo delle visioni dantesche: «Visione che eccede qualunque / fantasia» (il principe a Cenerentola). Se esiste qualcosa che è tragico e insieme beatifico in Walser, è proprio il vedere. Da lì vengono fuori la sua proverbiale gaiezza, l’eccitazione ammirevole e le escoriate benedizioni sulle offerte concrete del creato con piglio fanciullesco, commosso oltre ogni misura. Quella che Walser cerca è la perfetta letizia, la sintonia col Tutto. Non è Francesco: non riesce a trovarla (non ne ha forse il physique du rôle). Il vedere provoca in lui – nella depressiva concitazione che segue alla laudatio – una stortura ironica, la quale controbilancia e spesso soverchia i gradi della sublimità. È il destino di molti mistici-scrittori del Novecento, tra cui ovviamente Kafka: l’essere mistici senza sfondo, l’incapacità a indiarsi e la preterizione di ogni chiaro assenso, nonostante il desiderio ruggente di confondersi con le scintille del divino. Solo il sogno («sogneresti solo / se il sogno dovessi ghermire?») può dare vita alla vita, animarla nella sua attesa.
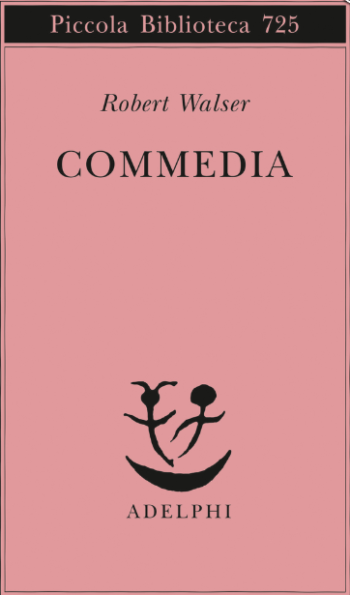 Non è un caso allora che i pezzi teatrali di Robert Walser si chiamino Commedia (traduzione di Cesare De Marchi, Adelphi, 234 pagine, 14 euro), né deve stupire che siano scritti sostanzialmente in versi – dimetri giambici – e siano per lo più la falsificazione di alcune fiabe dei Grimm con evidenti aggressioni della postmodernità («Non so come ho fatto a capitare / in questa fiaba» si chiede di nuovo, perplesso, il principe). In effetti, la figura del principe nei Dramolette è privilegiata in quanto confonditore di carte. In Biancaneve egli disdegna gentilmente la fanciulla e corteggia la matrigna: «Io vengo a voi, soave regina», donde la risposta spaesata «Come? Soave? Garbata apostrofe / la vostra». Tuttavia la regina non ama il comportamento «adolescenziale» del giovanotto, al quale preferisce la rusticità dell’«azzimato» cacciatore.
Non è un caso allora che i pezzi teatrali di Robert Walser si chiamino Commedia (traduzione di Cesare De Marchi, Adelphi, 234 pagine, 14 euro), né deve stupire che siano scritti sostanzialmente in versi – dimetri giambici – e siano per lo più la falsificazione di alcune fiabe dei Grimm con evidenti aggressioni della postmodernità («Non so come ho fatto a capitare / in questa fiaba» si chiede di nuovo, perplesso, il principe). In effetti, la figura del principe nei Dramolette è privilegiata in quanto confonditore di carte. In Biancaneve egli disdegna gentilmente la fanciulla e corteggia la matrigna: «Io vengo a voi, soave regina», donde la risposta spaesata «Come? Soave? Garbata apostrofe / la vostra». Tuttavia la regina non ama il comportamento «adolescenziale» del giovanotto, al quale preferisce la rusticità dell’«azzimato» cacciatore.
La madre di Walser, affetta da disturbi psichici, morì nel 1894, quando lui aveva solo sedici anni. Nei Ragazzi e nello Stagno è messo a fuoco molto da vicino il tema della maternità, o meglio della mancata maternità. Ed è proprio qui, paradossalmente, che il mistico scivola e perde contatto con il suo contenuto: la costante ricerca dell’essere amato, del sentirsi amato («voglio sapere una buona volta se conto qualcosa per lei o no», tuona Fritz simulando una caduta nello stagno per risvegliare l’affetto di sua madre) devia il percorso francescano dell’amare senza condizioni. Non c’è exstasis, perché non c’è vera uscita da sé; le pulsioni sublimanti sono introiettate e la bellezza resta una ferita, o forse una scottatura alla quale non si può porre rimedio, un’adamitica separazione dell’integrità persa dopo che la si era colta. È questo il problema centrale dell’opera di Walser che ricongiunge drammaticamente il vedere all’amare: come tornare al lieto gaudio di una condizione prelapsaria? In che modo osservare con immacolata certezza la realtà che ci circonda?  Il mondo walseriano si trasforma in un Eden su cui grava la minaccia dell’infelicità, della sciagura improvvisa. Gli amanti fantasticano, la famiglia riunita stappa una bottiglia di vino, nei boschi «gli abeti» sono «quasi colonne e il suolo di muschio / rivestito un tappeto», ma una sorda aria di malinconia – molto cechoviana – aleggia sulle cose e le mette in pericolo. È come se da un momento all’altro dovesse sopraggiungere una terribile catastrofe a squarciare definitivamente l’incanto. Il paradiso di Walser è, dunque, un edificio pericolante; nondimeno riesce a ridestare la nostra intorpidita ampiezza di lode, costringendo a riconquistare fiducia, non solo nella gioviale pazienza della natura, ma anche nell’uomo, nello sconosciuto, in particolare nel viandante e nel diverso: la fiducia incondizionata di Giuseppe, capace di accogliere quegli «uomini onorevoli» venuti a visitare il «tanto Atteso». Fiducia che, malgrado gli ambigui presagi, per così dire gli «umbriferi prefazi» di dantesca memoria sul futuro del neonato, spinge il padre putativo a dar la «buona notte», nelle girandole dei saluti, anche all’angelo, solerte difensore mandato dall’alto.
Il mondo walseriano si trasforma in un Eden su cui grava la minaccia dell’infelicità, della sciagura improvvisa. Gli amanti fantasticano, la famiglia riunita stappa una bottiglia di vino, nei boschi «gli abeti» sono «quasi colonne e il suolo di muschio / rivestito un tappeto», ma una sorda aria di malinconia – molto cechoviana – aleggia sulle cose e le mette in pericolo. È come se da un momento all’altro dovesse sopraggiungere una terribile catastrofe a squarciare definitivamente l’incanto. Il paradiso di Walser è, dunque, un edificio pericolante; nondimeno riesce a ridestare la nostra intorpidita ampiezza di lode, costringendo a riconquistare fiducia, non solo nella gioviale pazienza della natura, ma anche nell’uomo, nello sconosciuto, in particolare nel viandante e nel diverso: la fiducia incondizionata di Giuseppe, capace di accogliere quegli «uomini onorevoli» venuti a visitare il «tanto Atteso». Fiducia che, malgrado gli ambigui presagi, per così dire gli «umbriferi prefazi» di dantesca memoria sul futuro del neonato, spinge il padre putativo a dar la «buona notte», nelle girandole dei saluti, anche all’angelo, solerte difensore mandato dall’alto.
Le luci del crepuscolo avvampano, invece, sulla lunga passeggiata di Oskar ed Emma. Come un nume tutelare, la giovane ragazza accompagna il suo fidanzato nelle foreste e in ridenti cittadine. «Non vedo che te, / tu mi sei caro, mi sei tutto». Il finale sarà differente. «Un peso particolare negli effetti insieme stranianti e comici – sottolinea giustamente De Marchi nella Nota al testo – è dovuto al tessuto linguistico dei personaggi bambini e adolescenti, che si esprimono con una ricercatezza lessicale puntigliosa del tutto incompatibile con la loro età e condizione».
Camminatore indefesso – una volta da Berlino a Bienne, passeggiatina di 857 km! –, tetragono ai colpi di ventura, dallo humour gigantesco, quasi sproporzionato rispetto alle forze di chi legge, Walser è stato uno dei maggiori solutori dell’inquietudine, soprattutto nel tentativo di cercare la pienezza laddove sembrava perduta. «Mi manca qualcosa quando non sento musica, e quando la sento, allora sì che mi manca veramente qualcosa», affermò in una circostanza, a segnalare quella nostalgia del compimento, della maturità dei tempi che sempre lo ha accompagnato. Molto altro si potrebbe dire ma, come suggerisce Rosaspina destata da un incauto forestiero, «se restiamo ancora a parlare/ si fredda la minestra».
