Dostoevskij visto da Stefan Zweig
Vita di Fëdor
Un'esistenza miserabile, fatta di stenti, di prigionia, di umiliazioni, di lutti, con pochi alti e molti bassi. La biografia che lo scrittore austriaco ha dedicato al genio russo rivela aspetti inediti e spiega perché il regno dei personaggi usciti dalla sua penna “non è di questo mondo”
A chi ha dimestichezza con giornali, libri, periodici e siti web non sarà sfuggita la densità di riferimenti a Fëdor Dostoevskij, indicato come il grande scrittore per antonomasia, il demone della letteratura mondiale. Più di Tolstoj, di Balzac, di Flaubert e molti altri narratori del passato, oggi letti e riletti rimediando, probabilmente, a un diffuso pallore di certa produzione cartacea contemporanea (ed elettronica: costa relativamente poco “scaricare” i testi sui vari iPad, nulla se sono “fuori-diritti”). Dostoevskij è sinonimo dello scrutatore del profondo. Per la maggior parte dei lettori è più accessibile di Franz Kafka, ormai largamente aggettivizzato in relazione al senso di colpa, al labirinto della vita, all’incubo dell’accusa tenuta nascosta all’imputato. Se si conoscono i romanzi del russo, pochi, io credo, conoscono la sua vita miserabile, fatta di stenti, di prigionia, di umiliazioni, di lutti, in una girandola impazzita di alti (pochi) e bassi (tanti). Rimedia a questa quasi-ignoranza la bellissima biografia critica scritta da Stefan Zweig, il cui nome è già garanzia se si ha clemenza verso alcuni suoi tocchi retorici. Il libro in questione s’intitola appunto Dostoevskij, ed è pubblicato dalla Castelvecchi (118 pagine, 14,50 euro).
Dicevamo delle sue infinite miserie esistenziali. Che, in un certo senso, sono riassunte nel suo volto un po’ contadino. Un aspetto, annota Zweig, «terreo, quasi sudicio, con le gote incavate e raggrinzite; solcato da lunghe sofferenze, con la pelle screpolata, asciutta e arsa alla quale il vampiro di vent’anni di malattia (anche epilessia, ndr) ha tolto sangue e colorito». La sua immagine fa quasi rabbrividire: «Poi piano piano a questa iniziale sensazione si associa la timidezza, e dopo, appassionatamente, con crescente incanto, l’ammirazione». Insomma, un’insolita mistura di brivido e di grandezza. Dosteoevskij, tutto sommato, non è mai stato giovane. Anche da bambino non gli venne risparmiato alcun martirio. Zweig afferma che il suo destino «ricorda l’Antico Testamento: è eroico, non è del nostro tempo, né borghese». In effetti si possono contare su una sola mano i momenti di felicità e di soddisfazione. La sua biografia è contigua alla tragedia. Figlio di padre nobile (era medico militare) e di donna di stirpe contadina, Fëdor nasce nell’asilo dei poveri. E morirà in un quartiere di operai. Cinquantasei anni durissimi, iniziati in un angusto stanzino assieme al fratello. È silenzioso, assorbe il dolore, non inveisce, osserva la feccia umana, il disprezzo, l’isolamento degli ultimi. In lui c’è l’orgoglio della sopportazione. Di questo aspetto, così come di altri, non ne ha mai parlato.
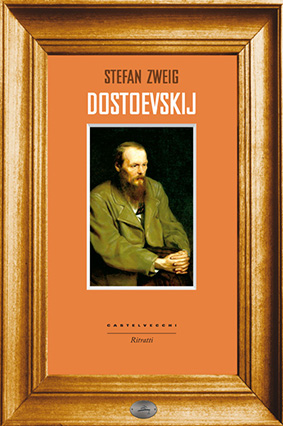 Con l’adolescenza c’è il tuffo consolatorio e visionario nel mondo dei libri, «eterna città libera di tutti gli insoddisfatti», come scrive Zweig. Incline a questo vizio, inevitabilmente si distanzia sempre di più dagli altri. Sono anni da “sottosuolo”, batte le strade della dissolutezza. Ha un disperato bisogno di soldi (costante della sua esistenza) e allora tenta la carriera militare. Ma sono anni cupi, senza il conforto di alcun amico. No, la divisa e il cameratismo non sono per lui, che si spia e comprende che il suo vero percorso è fuori da qualsiasi caserma. Meglio la solitudine, la fatica immane del vivere, se non altro per combattere «la mistica paura di morire» e nello stesso tempo il timore di entrare nella grotta della sua anima. Lavora preferenzialmente di notte, e traduce Eugénie Grandet di Balzac e Don Carlos di Schiller. Ma i soldi sono sempre pochi per lui che oscilla tra sperpero ed elemosina.
Con l’adolescenza c’è il tuffo consolatorio e visionario nel mondo dei libri, «eterna città libera di tutti gli insoddisfatti», come scrive Zweig. Incline a questo vizio, inevitabilmente si distanzia sempre di più dagli altri. Sono anni da “sottosuolo”, batte le strade della dissolutezza. Ha un disperato bisogno di soldi (costante della sua esistenza) e allora tenta la carriera militare. Ma sono anni cupi, senza il conforto di alcun amico. No, la divisa e il cameratismo non sono per lui, che si spia e comprende che il suo vero percorso è fuori da qualsiasi caserma. Meglio la solitudine, la fatica immane del vivere, se non altro per combattere «la mistica paura di morire» e nello stesso tempo il timore di entrare nella grotta della sua anima. Lavora preferenzialmente di notte, e traduce Eugénie Grandet di Balzac e Don Carlos di Schiller. Ma i soldi sono sempre pochi per lui che oscilla tra sperpero ed elemosina.
È in quella stagione che nasce la sua prima opera poetica, Povera gente. Siamo nel 1844, Dostoevskij ha ventritré anni. Forza il suo riserbo e consegna il manoscritto al poeta Nikolaj Nekrasov, chiedendogli un parere. Due giorni di silenzio, poi alle quattro del mattino sente trillare il campanello. Riconosce Nekrasov, che gli si getta tra le braccia, lo bacia e non finisce di inondarlo di elogi. È il primo attimo di vita felice per Fëdor. Il suo mentore si rivolge poi al critico allora più in voga, Belinskij, al quale annuncia: «Un nuovo Gogol è nato». Quello è scettico. Poi cambia all’improvviso dinanzi all’autore: «Ma comprendete voi stesso – gli dice in modo agitato – quel che avete creato!». Dostoevskij scende in strada in stato di ebbrezza, ride e piange. Sa di essere vicino alla gloria. Successivamente scrive il suo primo romanzo, Le notti bianche, la prima e ultima opera da uomo libero. Scrive e scrive, per pagare i debiti, per guadagnare il pane essenziale. Come riporta Stefan Zweig, «ora è murato per sempre nella prigione della letteratura».
Ma il destino, così ferocemente volubile, bussa per la seconda volta, all’alba. Nella sua stanza entrano alcuni ufficiali cosacchi che sigillano tutte le sue carte e faranno languire Fëdor in una cella della fortezza di San Paolo. Lui non sa di quale reato deve rispondere. Sa che si tratta di un equivoco, ma gli inquirenti sono sicuri: avrebbe partecipato alle discussioni di un gruppo di agitatori politici, la cosiddetta “cospirazione di Petrasevskij”. Lo condannano alla fucilazione. Lo legano a un palo, rulli di tamburi, occhi bendati. Ma a un certo punto un ufficiale alza la mano e blocca tutto: la condanna a morte è commutata nella prigionia. In Siberia. Per quattro anni, in catene, ha come amico un cane che ringhia, e come passatempi il suo pensiero, l’unico libro che gli è permesso, la Bibbia, e l’abitudine di contare i 1500 pali di quercia che delimitano il campo. Dopo la detenzione dura deve stare altri due anni in Siberia, in regime di semilibertà, col divieto assoluto di pubblicare una sola riga. Di questa esperienza farà solo un cenno in Umiliati e offesi. Poi ritorna a Pietroburgo, con la donna che ha sposato per ragioni non del tutto chiare. Nessuno ormai sa chi sia. Riprende la penna in mano, malgrado gli acciacchi infertigli dal rigore carcerario siberiano e scrive le sue Memorie da una casa morta. Si mormora che lo zar abbia pianto leggendo il suo testo. In ogni caso in un solo anno Dostoevskij torna alla ribalta letteraria. Ma la sfortuna torna ad accanirsi: muore la moglie e poco dopo il fratello col quale ha fondato un giornale, che oltretutto viene chiuso dalle autorità.
Creditori sempre alla porta visto che Fëdor si è sobbarcato i debiti delle due famiglie. Lavora tantissimo, ma intanto cominciano ad aggredirlo gli assalti epilettici. Sentendosi braccato dalla miseria e dagli strozzini, decide a malincuore di andare all’estero: Germania, Francia e Italia. Spiega Zweig, esagerando un po’: «Se la Siberia era stata il purgatorio delle sue sofferenze, l’esilio è stato il suo inferno». Effettivamente pensava alla sua Russia e regolarmente entrava nei bar dove sapeva di trovare giornali scritti in cirillico. Frequentava anche le gallerie d’arte, ma non per passione per i dipinti, solo per stare al caldo e leggere in pace. Non fece amicizia con nessuno. Praticamente le sue sole conoscenze, a parte i baristi, erano l’uomo del Monte dei pegni (cui consegnò un giorno perfino un paio di pantaloni) e l’impiegato di una banca per informarsi sull’arrivo di quel poco denaro spedito dagli editori russi.
A cinquantadue anni decide di tornare in patria e scopre che tutti parlano di lui, lo scrittore che ha oscurato la fama addirittura di Tolstoj e Turgenev. Raccogliendo le poche forze rimastegli offre ai posteri il suo testamento letterario: I fratelli Karamazov. La solitudine lo attanaglia. La dolce dattilografa che durante l’esilio lo sosteneva amorevolmente, era morta lontano dalla patria. Sfiancata dalla miseria. Gode, si fa per dire, della sua ormai immensa fama, ma per poco tempo. Muore il 9 febbraio del 1881. Una marea di persone accorre al suo modestissimo alloggio, ingombra strade e piazze. Gente di ogni ceto sociale cammina dietro la sua bara. Un gruppo di studenti progetta di agganciare al feretro le catene del forzato, ma la polizia interviene. Solo da morto Dostoevskij “vede” avverarsi il suo grande sogno: la Russia unita. Sogno breve anche questo: tre settimane dopo viene assassinato lo zar.
Stefan Zweig esamina poi in vari capitoli il nucleo narrativo del genio russo. Si può certo dissentire, sta di fatto che lo scrittore viennese, autore tra l’altro del celebratissimo Il mondo di ieri, esprime un suo punto di vista di forte spessore critico: «I protagonisti di Dostoevskij (contrariamente a quelli di altri grandi narratori, ndr) non cercano né trovano alcun rapporto con la vita reale, ecco la loro caratteristica. Essi non vogliono entrare nella realtà, vogliono superarla sin da principio nella ricerca dell’infinito. Il destino non esiste per loro in un senso esteriore ma solo in un senso interiore. Il loro regno non è di questo mondo». Fëdor si cala negli abissi dell’uomo con forza quasi demoniaca, il suo viaggio è diretto solo verso la profondità. In effetti all’autore di Delitto e castigo bastano poche righe per descrivere un personaggio. E in questo è molto distante, per esempio, dai colleghi francesi che all’inizio di un’opera impiegano anche due o tre pagine per “presentare” chi o quelli che poi si muoveranno all’interno della trama. Precisa Zweig: «Mentre gli altri tentano di rappresentare l’anima attraverso il corpo, lui plasma il corpo attraverso l’anima». Un punto di vista forse un poco estremistico, ma certamente acuto se non viene proprio preso alla lettera.
